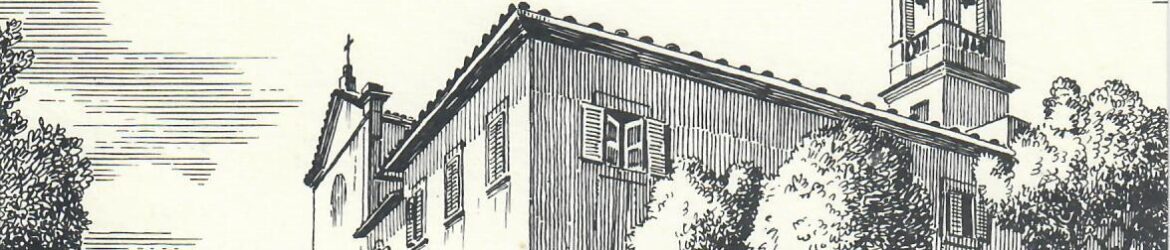di Stefano Tarocchi • Il progetto che nasce in questi giorni all’interno della Scuola di Medicina dell’Università di Firenze, fortemente voluto dal prof. Gianfranco Gensini, già preside, vuole portare all’attenzione dei futuri operatori sanitari le esigenze che la condizione religiosa del paziente pone a quanti lo curano nelle varie situazioni e in questo nostro tempo, stante l’odierna situazione multi-culturale e multi-religiosa. L’approccio scelto lascia ad altre circostanze le complesse tematiche della bioetica, per concentrarsi su un approccio e una modalità di cura, sempre più concentrate sull’unicità della persona.
Tale progetto si caratterizza come un vero e proprio corso opzionale della Scuola di Medicina, articolato in diversi incontri a più voci. Oltre a chi scrive, che rappresenta la Facoltà di Teologia dell’Italia Centrale (ma tendenzialmente anche il vasto e polimorfo orizzonte cristiano), ci saranno rappresentanti dell’ebraismo, del mondo islamico e di quelli buddista e induista.
Per quanto riguarda gli aspetti principali da offrire ai partecipanti, li riassumo schematicamente in nove punti:
- Spiritualità e preghiera: Molti pazienti vivono la malattia non necessariamente in maniera coerente con il vissuto passato: la stessa esperienza di preghiera, che pure si dimostra importante sotto vari profili, può essere ricuperata o totalmente respinta. L’ambiente che lo cura, attraverso tutti gli operatori in campo, dovrà essere attento a porre in essere una attenzione particolare perché sia libero di esprimere l’atteggiamento che più gli è consono.
- I rapporti con la famiglia: L’operatore sanitario dovrà cercare un rapporto con la famiglia, durante tutta la permanenza del paziente nella struttura sanitaria, informando sulla diagnosi, sulle terapie e gli esiti previsti delle cure. Il tutto senza escludere il paziente, che andrà comunque coinvolto, nei modi che si rendano possibili ed auspicabili, anche al fine di ottenere la sua collaborazione in tutto il trattamento.
- Il dolore: L’atteggiamento fino a qualche tempo fa trasmetteva l’ineluttabilità del dolore si direbbe ampiamente superato. L’esperienza della fede, soprattutto nelle malattie più gravi, può influenzare la percezione del dolore fino ad alzarne la soglia. Il medico dovrà guidarlo, con gli strumenti terapeutici a sua disposizione ma anche con la sua umanità, a ristabilire un movimento di reale avanzata verso la guarigione auspicata e possibile.
- La fine della vita: La condizione inevitabile che conduce alla fine della vita dovrà tenere conto, oltre che della persona in causa di quanti le sono (più o meno) legati. Dalla ribellione alla lotta alla rassegnazione, se la persona è in grado di viverla personalmente da soggetto partecipe, oppure dalla famiglia. Qui sorgono inevitabilmente problemi di ordine etico, che toccano questioni sensibili e complesse, quali l’accanimento terapeutico e l’eutanasia. L’operatore sanitario dovrà essere particolarmente concentrato per essere vicino al soggetto che vive quest’esperienza, ma anche ai familiari, dal momento in cui la notizia dell’evento ineluttabile viene trasmessa a tutte le fasi successive.
- La morte e la gestione della salma: La morte nella struttura sanitaria tende a riprodurre quell’atteggiamento di estraneità all’ordine della vita, tipico delle culture che danno importanza solo a chi abita un corpo perfetto, sano, piacevole allo sguardo. Per questo è vissuta senza quella tradizione sapienziale che la ritiene, per lo meno in certi contesti e date alcune condizioni, un fenomeno perfettamente naturale, sebbene doloroso. Il corpo del defunto assume una connotazione di sacralità in numerose culture: l’abitudine a vegliare la salma ed esprimere la partecipazione al dolore dei familiari ne è testimonianza, a prescindere dalla sorte che la attende dopo. La stessa cremazione, pur essendo per sé estranea al tessuto cristiano, è accettata nella comunità ecclesiale. Resta problematica per altre ragioni la dispersione delle ceneri o la collocazione nella casa stessa dove il defunto ha abitato con i familiari.
- Le differenze di genere: Differenze di genere possono avere importanza nel tipo di malattia presa in cura e nei modi differenti di tolleranza del dolore. Questo vale anche pure in quell’elemento, forse non così evidente nella nostra cultura occidentale e tendenzialmente permeata dal cristianesimo, ma ugualmente importante, del diverso approccio che un medico e un operatore di sesso differente da quello del paziente dovrebbe porre nell’analisi diagnostica e nella terapia di malattie (o di stati funzionali) collegati alla sfera sessuale, come pure della gestione, per esempio, dell’igiene quotidiana.
- I trapianti di organo: L’operatore cercherà di informare i familiari della persona della possibilità dell’espianto per la donazione degli organi. Tale informazione assumerà una diversa modalità quando la persona stessa avesse dato il suo assenso. Non andrà mai trascurata l’informazione circa il fatto che in nessun caso viene modificato il trattamento terapeutico, per favorire un pur lodevole atteggiamento verso altri pazienti che attendano la donazione medesima.
- L’alimentazione: La fede cristiana non sembra avere un impatto particolare su questo aspetto particolare, salvo fatto nelle persone che hanno un’età avanzata, memori di un’educazione attenta ad esempio all’astinenza dalla carne in alcuni periodi dell’anno. Prevale l’atteggiamento che associa l’alimentazione al benessere della persona e della sua salute.
- Considerazioni finali: Un tema ulteriore che credo rilevante sia quello dello stato della persona anziana, malata cronica, magari di una malattia che la priva delle sue capacità mentali. Se la persona, a casa o dalla residenza sanitaria assistita, viene condotta per un’urgenza nella struttura sanitaria, dovrebbe essere accolta nella sua piena umanità, e la medicina, senza inumani accanimenti, dovrà fornirle quanto le è possibile.