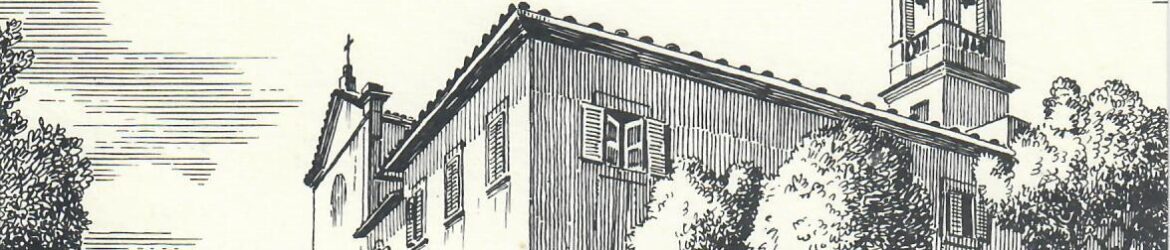di Stefano Tarocchi • È un fatto ben noto che gli studiosi biblici ortodossi non sono accompagnati da strumenti magisteriali paragonabili alla Dei Verbum del Concilio Vaticano IIdai documenti della stessa Pontificia Commissione Biblica, come la Sancta Mater Ecclesia, 1964 [sulla storicità dei Vangeli, preludio alla stessa Dei Verbum]; L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa,1993), fino all’esortazione post-sinodale Verbum Domini di Benedetto XVI (2010). Naturalmente senza dimenticare l’enciclica Divino Afflante Spiritudi Pio XII (1943), che segnò uno spartiacque decisivo per l’esegesi cattolica, che avrebbe puntato dritto al Vaticano II. Divino Afflante Spiritu fu pubblicata cinquant’anni dopo l’enciclica Providentissimus Deus di Leone XIII (1893).Aggiungo che Lo stesso Leone, non va dimenticato, costituì la “Pontificia Commissione Biblica” nel 1902, nove mesi avanti la morte, e nel 1909 Pio X fondò il Pontificio Istituto Biblico. Un autorevole studioso delle scienze bibliche ebbe a scrivere qualche anno fa che “per noi oggi è difficile renderci conto in un modo realistico della nube scura di atteggiamento reazionario che pendeva sopra l’interpretazione cattolica della Bibbia nella prima metà del ventesimo secolo” (J.A. Fitzmyer).
di Stefano Tarocchi • È un fatto ben noto che gli studiosi biblici ortodossi non sono accompagnati da strumenti magisteriali paragonabili alla Dei Verbum del Concilio Vaticano IIdai documenti della stessa Pontificia Commissione Biblica, come la Sancta Mater Ecclesia, 1964 [sulla storicità dei Vangeli, preludio alla stessa Dei Verbum]; L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa,1993), fino all’esortazione post-sinodale Verbum Domini di Benedetto XVI (2010). Naturalmente senza dimenticare l’enciclica Divino Afflante Spiritudi Pio XII (1943), che segnò uno spartiacque decisivo per l’esegesi cattolica, che avrebbe puntato dritto al Vaticano II. Divino Afflante Spiritu fu pubblicata cinquant’anni dopo l’enciclica Providentissimus Deus di Leone XIII (1893).Aggiungo che Lo stesso Leone, non va dimenticato, costituì la “Pontificia Commissione Biblica” nel 1902, nove mesi avanti la morte, e nel 1909 Pio X fondò il Pontificio Istituto Biblico. Un autorevole studioso delle scienze bibliche ebbe a scrivere qualche anno fa che “per noi oggi è difficile renderci conto in un modo realistico della nube scura di atteggiamento reazionario che pendeva sopra l’interpretazione cattolica della Bibbia nella prima metà del ventesimo secolo” (J.A. Fitzmyer).
Anche se il mondo ortodosso non ha alle spalle questo consolidato movimento, è possibile registrare una certa enfasi sulla materia, soprattutto nel clero più alto in grado. Si tratta comunque di una condizione che è piuttosto vaga riguardo il suo contenuto.
Tuttavia, anche la Chiesa ortodossa – che tra l’altro non ha respinto in epoca moderna la critica biblica – fino dalle primissime fasi della sua storia ha sviluppato la sua teologia sulla Bibbia. Non è senza significato, inoltre, che nella sua lunga storia essa ha rifiutato di accettare qualsiasi dogma che non fosse basato sulla Bibbia, per non parlare del fatto che tutte le dottrine conciliari del primo millennio della Chiesa hanno avuto una chiara fondazione biblica.
L’interpretazione della Scrittura è compresa come una spirale continua di lettura e rilettura dove tre differenti realtà interagiscono: il testo stesso nel suo stabilirsi storico e sociale, la tradizione teologica della sua ricezione, e le sfide moderne che un testo deve affrontare e a cui deve rispondere. È un terreno molto promettente da esplorare.
Semmai le difficoltà si registrano nel rifiuto di usare una traduzione moderna del testo neotestamentario, usato invece nella sua lingua originaria, il greco della koinê, di difficile comprensione alla maggior parte dei greci contemporanei.
In questo percorso si è inserito il Secondo Meeting Internazionale (Thessalia Conference Center, Melissatika, Volos, Grecia) dall’11 al 13 giugno: «The Baptism in the New Testament from an Orthodox and Roman Catholic perspective», che ha visto come protagonista la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale e l’Accademia Teologica di Volos, del patriarcato greco ortodosso di Demetriade (Tessaglia). Questa conferenza è stato sostenuto, rappresenta un contributo per l’enorme sforzo – qualcuno ha usato la parola “titanico” – della Chiesa cattolica e di quella Greco-Ortodossa verso la loro unione sacramentale.
Al proposito, secondo la tradizione l’Eucaristia e il Battesimo sono considerati come i due sacramenti che Gesù Cristo ha istituito per la Chiesa; perciò la “teologia eucaristica” e la “teologia battesimale” non sono né di valore diverso per quanto riguarda la ricerca dell’unità della Chiesa, né si escludono a vicenda, ma la prima è un elemento costitutivo e la condizione dell’altra.
Tuttavia, nonostante i progressi compiuti nel Concilio Vaticano II, finora il fondamento biblico della «nostra fede comune» – sono parole usate da uno dei relatori ortodossi – non è ancora considerato in molte riflessioni teologiche contemporanee dell’ortodossia come «prerequisito per interpretazioni più recenti» ed attualizzanti.
Al termine del Meeting gli studiosi cattolici e greco-ortodossi intervenuti si sono dati appuntamento a Firenze per il 2017, come già era avvenuto in occasione del Primo Convegno Internazionale di Studi Biblici («The present and future of Biblical Studies in the Orthodox and Roman Catholic Churches»– Aula Giovanni Benelli, 6-7 giugno 2013): «Testimonianze del Nuovo Testamento sul mistero della divina Eucaristia».