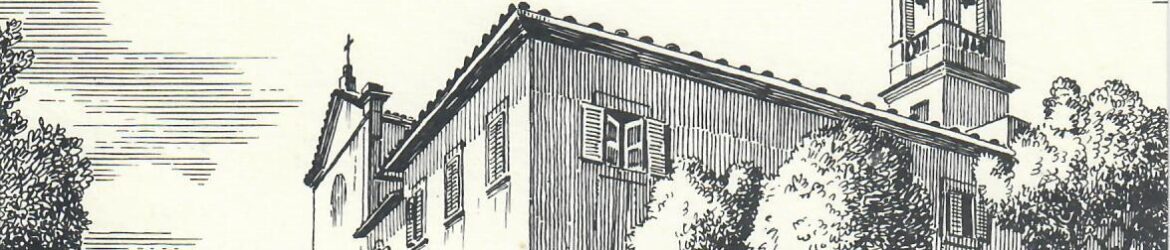di Stefano Tarocchi • Il racconto matteano della Risurrezione è a mio avviso un esempio straordinario di come si può (tentare di) gestire una notizia scomoda e addirittura (tentare di) manipolarla per i propri fini. E non solo la notizia, ma lo stesso evento della risurrezione.
di Stefano Tarocchi • Il racconto matteano della Risurrezione è a mio avviso un esempio straordinario di come si può (tentare di) gestire una notizia scomoda e addirittura (tentare di) manipolarla per i propri fini. E non solo la notizia, ma lo stesso evento della risurrezione.
Il vangelo di Matteo è l’unico che rompe il silenzio sul giorno successivo alla sepoltura di Gesù, a rigore di logica il sabato che coincide con la Pasqua ebraica, quando racconta: «il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti (lett: «i sommi sacerdoti») e i farisei, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quell’impostore, mentre era vivo, disse: “Dopo tre giorni risorgerò”. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: “È risorto dai morti”. Così quest’ultima impostura sarebbe peggiore della prima!». Pilato disse loro: «Avete le guardie: andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete». Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie»(Matteo 27,62-66).
Pilato, chiamato in causa, dalle autorità giudaiche che anticipano paradossalmente quanto dovrà avvenire e cercano di porvi rimedio alla loro maniera, decide di lasciare che siano i suoi interlocutori ad assicurare la custodia alla tomba.
Ricordiamoci di queste guardie, perché saranno la chiave del (duplice) tentativo di manipolazione, accanto a chi le ha usate.
Piero della Francesca nel suo straordinario capolavoro conservato a San Sepolcro, le ha raffigurate immerse totalmente in quel sonno che esprime la distanza umana da un fatto così straordinario e al tempo stesso l’incapacità di contenere l’evento della Pasqua, che non è possibile manipolare (o addomesticare per i propri fini). Come quanti hanno pensato di aver trovato la soluzione al problema in sé, la negazione tout court della Risurrezione, attraverso il mezzo più elementare della corruzione: il denaro. E tutto questo nonostante che, in aggiunta alla custodia umana, la tomba fosse stata bloccata strategicamente con dei sigilli, violati non da ipotetici rapitori ma dalla potenza della manifestazione divina.
Nel racconto di Matteo, la risurrezione sfugge semplicemente alle guardie che dovevano custodire la tomba: l’unica reazione è quella davanti all’angelo che ha il compito di rotolare la pietra che tiene chiuso il sepolcro: solo «per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte» (Matteo 28,64). Paradossalmente, queste guardie testimoniano l’infondatezza della ragione per cui erano state collocate alla tomba di Gesù: se la pietra era ancora al suo posto, non poteva essere stato rapito nessun corpo. E tuttavia nessun corpo era ormai nella tomba: «So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto» (Matteo 28,5-6).
L’evangelista ha, però, in serbo un’altra sorpresa: dalla tomba si dipartono due movimenti divergenti. Le donne che vanno ad annunciare ai discepoli l’evento della risurrezione, per convocarli in Galilea, dove lo vedranno (mentre esse già lo incontrano sulla loro strada); e alcune (non tutte!), le guardie che riportano l’accaduto ai loro mandanti (Matteo 28,11).
Tutto sembrerebbe indicare il fallimento della mossa precedente delle autorità giudaiche, in quella terra di nessuno che il potere disegna sempre per quelli che lo abitano, e sembrerebbe renderli immuni dal senso di fallimento.
Il potere mette a disposizione anche il denaro e il denaro emerge ancora nel racconto. Quindi gli esponenti dell’intellighenzia di Gerusalemme decidono di mettere (ancora) mano alla borsa. Così, scrive ancora Matteo, i sommi sacerdoti «si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: “I suoi discepoli sono venuti di notte e l’hanno rubato, mentre noi dormivamo”. E se mai la cosa venisse all’orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione» (Matteo 28,12-14).
Il denaro che ha fornito la custodia armata e fallimentare alla tomba corrompe ancora una volta, e paga chi ha totalmente mancato al proprio compito iniziale: pertanto «quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute (lett: «come era stato insegnato loro»). Così questo racconto [ho logos nell’originale!] si è divulgato fra i Giudei fino ad oggi» (Matteo 28,15).
E qui nasce la seconda manipolazione, quella della notizia, condotta attraverso una sorta di parodia dello stesso kerigma cristiano, utilizzando la stessa identica terminologia, ancora più evidente nel testo originale.
Il potere tenta di piegare la verità della risurrezione, mostrando così la propria intima debolezza, e in aggiunta sostiene di poter manipolare anche l’autorità di Roma. Ha addirittura elaborato anche il suo “comunicato stampa”: «Dite così: “I suoi discepoli sono venuti di notte e l’hanno rubato, mentre noi dormivamo”».
In esso non sostiene neanche che le guardie sono state sopraffatte, ma sono venute meno nel loro compito perché sopraffatte dal sonno. Questa è l’ultima perfidia: al corrotto in pratica viene addossata anche la colpa e la responsabilità del corruttore.
Matteo, infine, aggiunge per il suo lettore che il «racconto» del rapimento si è diffuso fra i Giudei fino al giorno in cui viene scritto il “suo” racconto, quel Vangelo che è ancora oggi nelle nostre mani. Possiamo ritenere che è esattamente questo racconto, insieme a quelli di Marco, Luca (e Giovanni), a dare l’esatta ricostruzione degli avvenimenti relativi alla risurrezione: qui è come se le donne, anziché limitarsi ai soli discepoli, fossero arrivate fino a noi per chiamarci nella Galilea del nostro tempo, in cui vediamo ancora oggi presente e vivo il Risorto.