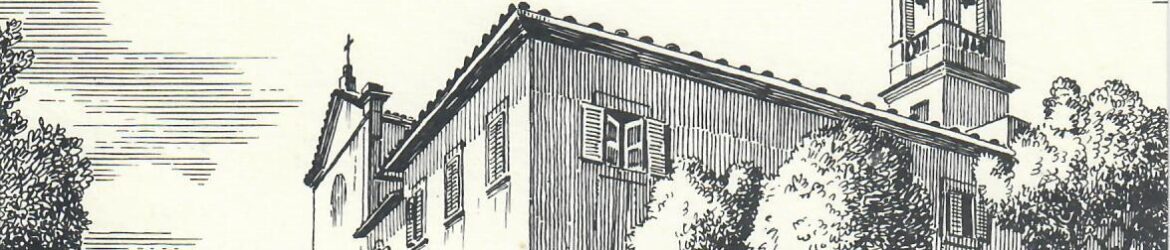di Stefano Tarocchi • Lo scorso 2 giugno, vigilia della festa liturgica del Sacro Cuore di Gesù, rispettivamente nelle tre basiliche di S. Giovanni in Laterano, di S. Maria Maggiore e di S. Paolo fuori le Mura, papa Francesco ha dettato ai presbiteri convenuti per il loro Giubileo altrettante meditazioni sul tema della misericordia. Essa – ha esordito Francesco prima di affrontare la vera e propria meditazione iniziale, «ci permette di passare dal sentirci oggetto di misericordia al desiderio di offrire misericordia». Il papa ha quindi addirittura coniato un neologismo nella lingua italiana, peraltro assai espressivo, quando ha osato parlare ai preti dell’azione del “misericordiare” per poter “essere misericordiati”, «un tipo di azione che è onninclusiva: la misericordia include tutto il nostro essere – viscere e spirito – e tutti gli esseri». Infatti «non si può meditare sulla misericordia senza che tutto si metta in azione».
di Stefano Tarocchi • Lo scorso 2 giugno, vigilia della festa liturgica del Sacro Cuore di Gesù, rispettivamente nelle tre basiliche di S. Giovanni in Laterano, di S. Maria Maggiore e di S. Paolo fuori le Mura, papa Francesco ha dettato ai presbiteri convenuti per il loro Giubileo altrettante meditazioni sul tema della misericordia. Essa – ha esordito Francesco prima di affrontare la vera e propria meditazione iniziale, «ci permette di passare dal sentirci oggetto di misericordia al desiderio di offrire misericordia». Il papa ha quindi addirittura coniato un neologismo nella lingua italiana, peraltro assai espressivo, quando ha osato parlare ai preti dell’azione del “misericordiare” per poter “essere misericordiati”, «un tipo di azione che è onninclusiva: la misericordia include tutto il nostro essere – viscere e spirito – e tutti gli esseri». Infatti «non si può meditare sulla misericordia senza che tutto si metta in azione».
Pertanto – ha aggiunto Francesco, nella preghiera, non fa bene intellettualizzare». Mentre «rapidamente, con l’aiuto della Grazia, il nostro dialogo con il Signore deve concretizzarsi su quale mio peccato richieda che si posi in me la Tua misericordia, Signore, dove sento più vergogna e più desidero riparare». Così «se le nostre strutture non si vivono e non si utilizzano per meglio ricevere la misericordia di Dio e per essere più misericordiosi con gli altri, possono trasformarsi in qualcosa di molto diverso e controproducente». Questo per raggiungere i desiderati «frutti di conversione della nostra mentalità istituzionale».
La vera e propria meditazione (I. «Dalla distanza alla festa») ha preso spunto dalla parabola del Padre misericordioso (Lc 15,11-31). Francesco circa il figlio fuggito da casa ha richiamato la sua nostalgia del figlio minore, richiamando l’etimologia greca: ha detto il papa che la nostalgia «è un sentimento potente. Ha a che fare con la misericordia perché ci allarga l’anima. Ci fa ricordare il bene primario – la patria da cui proveniamo – e risveglia in noi la speranza di ritornare», come sottolinea l’etimologia del termine greco: il nostos algos ossia il “dolore del ritorno”».
Quando questo si verifica il papa ha felicemente evidenziato il rapporto tra il padre e il figlio: questi viene accolto così com’è, e condotto alla festa: «sporco, ma vestito a festa». In quello stato di «vergognata dignità», dice Francesco, «possiamo percepire come batte il cuore di nostro Padre. Possiamo immaginare che la misericordia ne sgorga come sangue».
Questo sangue è il «Sangue di Cristo, sangue della Nuova ed Eterna Alleanza di misericordia, versato per noi e per tutti in remissione dei peccati. Questo sangue lo contempliamo mentre entra ed esce dal suo Cuore, e dal cuore del Padre». Esso, ha aggiunto il papa, «è l’unico nostro tesoro, l’unica cosa che abbiamo da offrire al mondo: il sangue che purifica e pacifica tutto e tutti. Il sangue del Signore che perdona i peccati». Parlando quasi di una condizione costitutiva della misericordia, ha chiesto ai preti un gesto ulteriore: «nella nostra preghiera, serena, che va dalla vergogna alla dignità e dalla dignità alla vergogna – tutte e due insieme – chiediamo la grazia di sentire tale misericordia come costitutiva di tutta la nostra vita; la grazia di sentire come quel battito del cuore del Padre si unisca con il battito del nostro».
Perciò «l’importante è che ciascuno si ponga nella tensione feconda in cui la misericordia del Signore ci colloca: non solamente di peccatori perdonati, ma di peccatori a cui è conferita dignità. Il Signore non solamente ci pulisce, ma ci incorona, ci dà dignità». Così Simon Pietro offre «l’immagine ministeriale di questa sana tensione» per «situarci qui, nello spazio in cui convivono la nostra miseria più vergognosa e la nostra dignità più alta». E ancora, «sporchi, impuri, meschini, vanitosi – è peccato di preti, la vanità – egoisti e, nello stesso tempo, con i piedi lavati, chiamati ed eletti, intenti a distribuire i pani moltiplicati, benedetti dalla nostra gente, amati e curati. Solo la misericordia rende sopportabile quella posizione».
Quindi il papa si è chiesto nella nuova meditazione (II. «il ricettacolo della misericordia») «perché è così feconda questa tensione fra miseria e dignità, fra distanza e festa?». Questa la risposta: «è feconda perché mantenerla nasce da una decisione libera. E il Signore agisce principalmente sulla nostra libertà, benché ci aiuti in ogni cosa. La misericordia è questione di libertà». Possiamo vivere «senza averne coscienza e senza chiederla esplicitamente, finché uno si rende conto che “tutto è misericordia”, e piange con amarezza di non averne approfittato prima, dal momento che ne aveva tanto bisogno». «L’unico eccesso davanti alla eccessiva misericordia di Dio è eccedere nel riceverla e nel desiderio di comunicarla agli altri». Ma «la misericordia è il vero atteggiamento di vita che si oppone alla morte, che è l’amaro frutto del peccato». Così «il Signore non solo non si stanca di perdonarci, ma rinnova anche l’otre nel quale riceviamo il suo perdono. Utilizza un otre nuovo per il vino nuovo della sua misericordia, perché non sia come un vestito rattoppato o un otre vecchio». «Un cuore che sa di essere ricreato grazie alla fusione della sua miseria con il perdono di Dio, e per questo è un cuore che ha ricevuto misericordia e dona misericordia». «Nell’esercizio di questa misericordia che ripara il male altrui, nessuno è migliore, per aiutare a curarlo, di colui che mantiene viva l’esperienza di essere stato oggetto di misericordia circa il medesimo male». Maria «è il recipiente semplice e perfetto, con il quale ricevere e distribuire la misericordia. Il suo “sì” libero alla grazia è l’immagine opposta rispetto al peccato che condusse il figlio prodigo verso il nulla. Ella porta in sé una misericordia che è al tempo stesso molto sua, molto della nostra anima e molto ecclesiale. Come afferma nel Magnificat: si sa guardata con bontà nella sua piccolezza e sa guardare come la misericordia di Dio raggiunge tutte le generazioni». Francesco ha quindi ripreso il discorso tenuto lo scorso anni ai vescovi messicani «l’unica forza capace di conquistare il cuore degli uomini è la tenerezza di Dio. Ciò che incanta e attrae, ciò che piega e vince, ciò che apre e scioglie dalle catene non è la forza degli strumenti o la durezza della legge, bensì la debolezza onnipotente dell’amore divino, è la forza irresistibile della sua dolcezza e la promessa irreversibile della sua misericordia».
Nell’ultima parte del ritiro (III. «il buon odore di Cristo e la luce della sua misericordia») Francesco si sofferma sulle opere di misericordia. Dopo aver invitato i prebiteri a chiedere al Signore «uno sguardo che impari a discernere i segni dei tempi nella prospettiva di “quali opere di misericordia sono necessarie oggi per la nostra gente” per poter sentire e gustare il Dio della storia che cammina in mezzo a loro». D’altronde «nelle opere di misericordia siamo sempre benedetti da Dio e troviamo aiuto e collaborazione nella nostra gente. Non così per altri tipi di progetti, che a volte vanno bene e altre no, e alcuni non si rendono conto del perché non funziona e si rompono la testa cercando un nuovo, ennesimo piano pastorale, quando si potrebbe semplicemente dire: non funziona perché gli manca misericordia… Se non è benedetto è perché gli manca misericordia»
Ma proprio l’incipit della terza meditazione è di quelli che non ammette repliche: «il nostro popolo perdona molti difetti ai preti, salvo quello di essere attaccati al denaro. Il popolo non lo perdona. E non è tanto per la ricchezza in sé, ma perché il denaro ci fa perdere la ricchezza della misericordia. Il nostro popolo riconosce “a fiuto” quali peccati sono gravi per il pastore, quali uccidono il suo ministero perché lo fanno diventare un funzionario, o peggio un mercenario». E prosegue: «la grazia che chiediamo in questa preghiera è quella di lasciarci usare misericordia da Dio in tutti gli aspetti della nostra vita e di essere misericordiosi con gli altri in tutto il nostro agire. Per noi sacerdoti e vescovi, che lavoriamo con i Sacramenti, battezzando, confessando, celebrando l’Eucaristia…, la misericordia è il modo di trasformare tutta la vita del popolo di Dio in “sacramento”».
Ecco allora la «preghiera con la peccatrice perdonata (cfr Gv 8,3-11), per chiedere la grazia di essere misericordiosi nella Confessione, e un’altra sulla dimensione sociale delle opere di misericordia». È vero che «nel suo dialogo con la donna il Signore apre altri spazi: uno è lo spazio della non condanna. Il Vangelo insiste su questo spazio che è rimasto libero. Ci colloca nello sguardo di Gesù e ci dice che “non vede nessuno intorno ma solo la donna”. E poi Gesù stesso fa guardare intorno la donna con la domanda: “Dove sono quelli che ti classificavano”».
Il papa ha calcato su quest’ultimo verbo «perché dice di ciò che tanto rifiutiamo come il fatto che ci etichettino e ci facciano una caricatura». Si direbbe essere uno dei criteri con cui Francesco (in queste meditazioni l’attaccamento al denaro e la vanità) sferza gli uomini di Chiesa, preti, vescovi e religiosi, e che normalmente gli procura immeritate critiche: come dice la lettera agli Ebrei «Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d’animo quando sei ripreso da lui; perché il Signore corregge colui che egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio.
È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che non viene corretto dal padre? (Eb 12,5-7).
Al termine del discorso, papa Francesco enuclea davanti ai presbiteri le caratteristiche del ministero della riconciliazione, che dovrà essere 1. «Segnoe strumento di un incontro. … Segno vuol dire che dobbiamo attrarre. … Un segno dev’essere coerente e chiaro, ma soprattutto comprensibile»; 2. «non autoreferenziale, per dirlo in maniera difficile. Nessuno si ferma al segno una volta che ha compreso la cosa; nessuno si ferma a guardare il cacciavite o il martello, ma guarda il quadro che è stato ben fissato. Siamo servi inutili», non necessari; ma per questo il papa richiama alla 3. disponibilità. Che sia pronto all’uso lo strumento, che sia visibile il segno. L’essenza del segno e dello strumento è di essere mediatori, disponibili. Forse qui si trova la chiave della nostra missione in questo incontro della misericordia di Dio con l’uomo»; occorrerà, quindi, anche 4. imparare dai buoni confessori, quelli che hanno delicatezza con i peccatori e ai quali basta mezza parola per capire tutto, come Gesù con l’emorroissa, e proprio in quel momento esce da loro la forza del perdono … senza avere mai lo sguardo del funzionario, di quello che vede solo “casi” e se li scrolla di dosso».
Lasciamo Francesco parlare infine ancora una volta: «chiediamo due grazie al Buon Pastore: quella di lasciarci guidare dal sensus fidei del nostro popolo fedele, e anche dal suo “senso del povero”. Entrambi i “sensi” sono legati al “sensus Christi”, di cui parla san Paolo, all’amore e alla fede che la nostra gente ha per Gesù». Per questo la meditazione si è mutata in preghiera: «non permettere che il tuo popolo, Signore, si separi da Te. Che niente e nessuno ci separi dalla tua misericordia, la quale ci difende dalle insidie del nemico maligno. Così potremo cantare le misericordie del Signore insieme a tutti i tuoi santi quando ci comanderai di venire a Te».