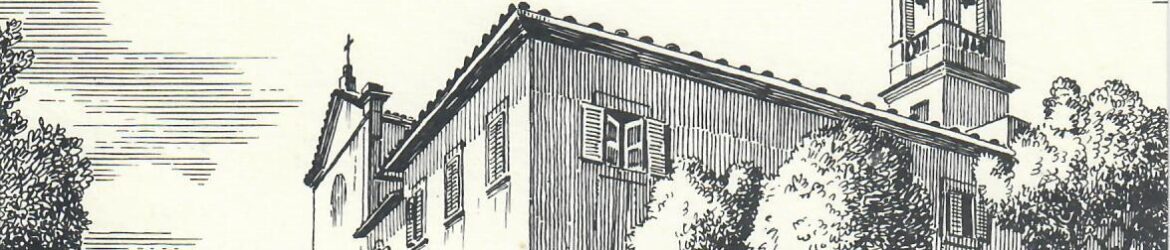di Stefano Tarocchi • La pagina della liturgia festiva che, secondo l’evangelista Matteo, racconta la professione di fede dell’apostolo Pietro, avvenuta «nella regione di Cesarèa di Filippo» (Mt 16,13; o nei villaggi intorno alla città, come dice il vangelo di Marco: Mc 8,27), aggiunge alla professione di fede le parole di Gesù: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli» (Mt 16,17-19).
di Stefano Tarocchi • La pagina della liturgia festiva che, secondo l’evangelista Matteo, racconta la professione di fede dell’apostolo Pietro, avvenuta «nella regione di Cesarèa di Filippo» (Mt 16,13; o nei villaggi intorno alla città, come dice il vangelo di Marco: Mc 8,27), aggiunge alla professione di fede le parole di Gesù: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli» (Mt 16,17-19).
La città dove questi eventi si svolgono, già dedicata al dio Pan (oggi tale caratteristica si ritrova nel nome attuale Banyas) era già stata annessa nel 20 a.C. al regno di Erode il Grande, era stata fondata nel III secolo a.C. Il tetrarca Erode Filippo, dopo che il padre aveva fatto costruire un tempio dedicato ad Augusto, sullo stesso sito fonda una nuova città, dedicata all’imperatore Tiberio: viene chiamata Cesarea di Filippo per distinguerla dalla città di Cesarea Marittima, anch’essa fondata da Erode il grande in onore dell’imperatore Augusto.
È significativo in questo testo il nome con cui Gesù chiama l’apostolo, che precedentemente era rammentato come «Simon Pietro» (Mt 16,16). Troviamo questi due nomi accostati in Lc 5,8; Gv 1,40; 6,8.68; 13,6.9.24.36; 18,10.15.25; 20,2.6; 21,2.3.7.11.15; 2 Pt 1,2.
Il solo Vangelo di Marco sembra distinguere con maggiore accuratezza riguardo all’apostolo, tra l’antico nome di Simone e quello che Gesù gli assegna nella scelta dei Dodici. Così abbiamo: «Simone, al quale impose il nome di Pietro» (Mc 3,16). Qualcosa di analogo troviamo anche in Luca («Simone, al quale diede anche il nome di Pietro»: Lc 6,14), ma non in Matteo, che ha semplicemente «Simone, chiamato Pietro» (Mt 10,2). E del resto il Vangelo di Matteo aveva esordito con la chiamata dei primi due discepoli, ricordando Gesù, che quando: «camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello (Mt 4,18). E da quel momento in poi sarà sempre “Pietro”, eccetto che in Mt 16,16 (Mt 8,14; 14,28.29; 15,15; 16,22.23; 17,1.4.24; 18,21; 19,27; 26,33.35.37.40.58.69.73.75). Nel solo quarto Vangelo troviamo una variante significativa: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro» (Gv 1,42).
Peraltro, questa forma aramaica si ritrova altrove solo nelle lettere di Paolo (1 Cor 3,22; 9,5; Gal 2,9.11): di fatto aveva finito per prevalere l’altra forma, prima greca e poi latina: Petros / Petrus, e che è passata nelle lingue moderne. Ora Petros significa esattamente “pietra”, e non “roccia” (dovremmo usare il femminile), come ci si potrebbe maggiormente aspettare: ma il vangelo di Matteo introduce un gioco di parole, per cui è verosimile che i due termini acquistino il medesimo significato.
Nel Vangelo di Marco sostituisce l’uso di Simone dalla chiamata in avanti, compresa la professione di fede, eccetto che in Mc 14,37, quando Gesù, che si trovava nel Getsemani: «venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora?».
Si tratta sempre del medesimo apostolo, ma Gesù, significativamente, lo chiama Simone, come a richiamare un tradimento della scelta stessa che lo ha inserito nel gruppo dei Dodici.
Ma torniamo alla professione di fede: Gesù si rivolge all’apostolo chiamandolo «Simone, figlio di Giona»; è l’unica volta che Gesù si esprime in questo modo. Va detto subito che il testo originale riporta il ricalco aramaico «Barjonah», o in alcuni codici «Bar-Jonah»: entrambi non si trovano altrove nelle Scritture. La traduzione italiana usa quest’ultimo modo e lo rende come patronimico (nome del padre): «figlio di Giona». Si incontrano infatti nei Vangeli nomi come «Bartimeo» (Mc 10,46: «il figlio di Timeo, Bartimeo»), oppure «Bartolomeo» (Mc 3,18; Mt 10,3; Lc 6,14; At 1,13), o addirittura un Bar-Iesus (At 13,46) ed altri.
Ora, pare che al tempo di Gesù (Gnilka), il nome del profeta Giona non fosse più in uso. «Jonah» infatti potrebbe essere la rara abbreviazione di “Johanan”, «Giovanni». Nel quarto vangelo abbiamo la riprova di una verosimiglianza: «Simone, figlio di Giovanni» (Gv 1,42; 21,5.16.17).
Quello che è certo è che la professione di fede pronunciata da Pietro in una forma così completa («Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16,16), che Gesù impone ai discepoli di non divulgare nelle sue implicazioni («ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo»: Mt 16,20) si fonda sulla rivelazione divina e non è frutto della sua umanità o delle sue capacità («né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli»: Mt 16,17). Nonostante, ed oltre i suoi fallimenti, soprattutto durante la passione, nonostante i suoi dubbi e la sua poca fede («Uomo di poca fede, perché hai dubitato?»: Mt 14,31; cf. 28,17), egli è e rimane la roccia della Chiesa del Cristo, colui che garantisce che la sua professione di fede è situata all’interno della rivelazione del Padre.