«Noi annunciamo Cristo crocifisso»
Il Mantello della Giustizia – Marzo 2024
 di Stefano Tarocchi · Il tema della croce di Gesù Cristo, che è centrale in questo tempo di Pasqua, è uno dei temi più diffusi, e al tempo stesso meno conosciuti, dell’annuncio cristiano.
di Stefano Tarocchi · Il tema della croce di Gesù Cristo, che è centrale in questo tempo di Pasqua, è uno dei temi più diffusi, e al tempo stesso meno conosciuti, dell’annuncio cristiano.
Prendiamo un testo come quello che è affidato alla liturgia delle domeniche di Quaresima di quest’anno: «mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini» (1 Cor 2,22-25).
di Stefano Tarocchi · Il tema della croce di Gesù Cristo, che è centrale in questo tempo di Pasqua, è uno dei temi più diffusi, e al tempo stesso meno conosciuti, dell’annuncio cristiano.
Prendiamo un testo come quello che è affidato alla liturgia delle domeniche di Quaresima di quest’anno: «mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini» (1 Cor 2,22-25).
Non si tratta dell’unico annuncio in cui Paolo affronta il tema della croce. Infatti, leggiamo ancora nella stessa prima lettera ai Corinzi: «Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l’intelligenza degli intelligenti. Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? Dov’è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione». E ancora: «mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini» (1 Cor 1,17-25).
E quindi: «Anch’io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio» (1Cor 2,1-5).
Questa è normalmente la base sulla quale si contrappone l’esito, apparentemente negativo, del discorso che nel libro degli Atti riporta le parole dell’apostolo Paolo. Il tutto sulla base della ricostruzione del progetto che è in mente all’autore di questo libro, il secondo di Luca, autore del terzo vangelo.
Riportiamo qui un esempio emblematico, le parole del Papa Francesco: «l’apostolo Paolo venne ad Atene, ed è rimasto colpito quando ha visto nell’areopago tanti monumenti agli dèi. E lui ha pensato di parlare di questo: “Voi siete un popolo religioso, io vedo questo… Mi attira l’attenzione quell’altare al ‘dio ignoto’. Questo io lo conosco e vengo a dirvi chi è”. E incominciò a predicare il Vangelo. Ma quando arrivò alla croce e alla risurrezione si scandalizzarono e se ne andarono via (cf. At 17,22-33). C’è una cosa che la mondanità non tollera: lo scandalo della Croce. Non lo tollera. E l’unica medicina contro lo spirito della mondanità è Cristo morto e risorto per noi, scandalo e stoltezza (cf. 1Cor 1,23)» (Francesco, Omelia del 16 maggio 2020).
Nell’incontro di San Paolo con la grande città di Atene, ormai ridotta a modesto villaggio non lontano dalla metropoli di Corinto, emerge la ricerca, peraltro di straordinaria attualità, di un linguaggio straordinariamente capace di intercettare l’ambiente culrurale dei suoi destinatari.
In quel testo (At 17,15-34), che rimandiamo agli stessi lettori, l’autore degli Atti ricostruisce l’annuncio della risurrezione di Cristo, attraverso di quell’ambiente che ha come passatempo principale ascoltare tutte le novità che accadono sulla sua «piazza»: stiamo parlando dell’‘areopago’, la «rupe di Ares». Esso «l’Areopago va inteso non tanto come un luogo (dove gli oratori potevano parlare liberamente e gli ascoltatori erano sempre a portata di mano) quanto come il consiglio, che si riuniva sul monte» (Fitzmyer).
Situato presso l’acropoli e divenuto il più antico tribunale di Atene, fu ridotto poi al solo giudizio sui delitti di sangue – oggi addirittura l’Areopago designa la corte suprema della Grecia in materia di diritto civile e penale.
Ma il libro degli Atti dice che «tutti gli Ateniesi e gli stranieri là residenti non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità» (At 17,21).
Pertanto, non c’è nessuna opposizione fra ciò che accaduto ad Atene secondo la descrizione dell’autore e quello che Paolo scrive ai cristiani di Corinto.
Se è vero che «gli Atti degli Apostoli non sono terminati» perché «continuano nella storia della Chiesa e di ogni battezzato» (Penna), dentro ogni annuncio cristiano si trova la verità del Vangelo, nella sua scomoda certezza.
Se negli Atti degli apostoli è racchiuso il tentativo di annunciare a una cultura diversa rispetto a quella del popolo ebraico i fatti che riguardano la risurrezione di Cristo, non troviamo nessun tentativo di ammorbidire la verità del Vangelo con un linguaggio forbito. Si tratta comunque di un annuncio che si fa ascoltare perché non c’è nessuna fede senza un annuncio: «non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato? Dunque, la fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo (Rom 10,16-17)».
Dentro ogni annuncio c’è la certezza che Cristo ha salvato tutti gli uomini attraverso la stoltezza della sua croce. E il Paolo della lettera ai Corinzi non contrasta con il Paolo degli Atti: le due narrazioni, quella dello scritto e dell’apostolo, e la lettura che ne fa l’autore del terzo Vangelo, sono due metodi complementari che permettono di afferrare il dono della salvezza attraverso l’obbedienza, cioè l’ascolto, della fede (cf. Rom 1,5).
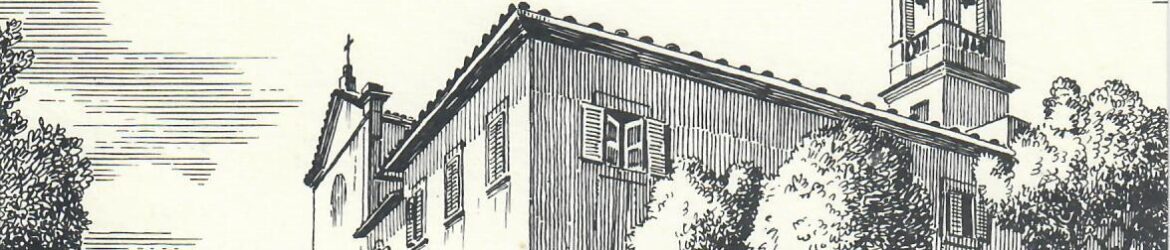
 di Stefano Tarocchi · Il tema della croce di Gesù Cristo, che è centrale in questo tempo di Pasqua, è uno dei temi più diffusi, e al tempo stesso meno conosciuti, dell’annuncio cristiano.
di Stefano Tarocchi · Il tema della croce di Gesù Cristo, che è centrale in questo tempo di Pasqua, è uno dei temi più diffusi, e al tempo stesso meno conosciuti, dell’annuncio cristiano.