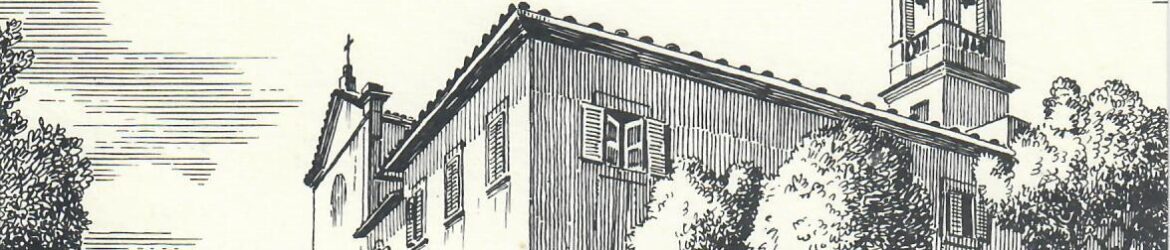Il giudizio di Cristo sulla storia degli uomini
Il mantello della giustizia- Agosto 2019
 di Stefano Tarocchi • Il libro dell’Apocalisse descrive con lucidità estrema la scena dell’abbraccio finale tra l’umanità e Dio: siamo nella visione del sigillo sopra i centoquarantaquattromila (dodici per dodici per mille), rappresentanti delle dodici tribù d’Israele che ha fatto versare fiumi d’inchiostro. Il numero significa la totalità (mille) dell’antico (il primo dodici) e del nuovo Israele (la chiesa di Cristo, il secondo dodici).
di Stefano Tarocchi • Il libro dell’Apocalisse descrive con lucidità estrema la scena dell’abbraccio finale tra l’umanità e Dio: siamo nella visione del sigillo sopra i centoquarantaquattromila (dodici per dodici per mille), rappresentanti delle dodici tribù d’Israele che ha fatto versare fiumi d’inchiostro. Il numero significa la totalità (mille) dell’antico (il primo dodici) e del nuovo Israele (la chiesa di Cristo, il secondo dodici).
Essi sono seguiti da una «moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani» (Ap 7,9).
È il motivo per cui letteralmente il testo originale suona come «dopo queste cose io vidi: e guarda anche tu» (Vanni), quando «uno degli anziani allora si rivolse a me [ossia a Giovanni] e disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». (Ap 7,13-17).
Il libro di Giovanni ripropone quasi al suo epilogo una visione analoga: «e vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate». E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,1-5).
Il linguaggio è naturalmente quello tipico del libro della rivelazione di Giovanni – “apocalisse” significa esattamente questo –, ma il tema è percorso nella lunga sezione del vangelo di Matteo che descrive gli avvenimenti dei tempi ultimi.
L’evangelista Matteo ha negli occhi la distruzione della città santa del 70 d.C., quando inserisce l’invito di Gesù alla vigilanza (Mt 24,42: «Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà»), nell’attesa della venuta del Signore, che avverrà al momento in cui «il Figlio dell’uomo [verrà] sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria» (Mt 24,30).
Questo insegnamento procede anche nella parabola delle dieci ragazze sagge (Mt 25,1-12), che non a caso ripete il medesimo invito: «Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora» (Mt 25,13; cf. Mc 13,35.37; Lc 12,37).
La vigilanza che esclude il sonno ritorna nell’agonia di Gesù al Getsemani: «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me» (Mt 26,38; cf. Mt 26,41; Mc 14,34.38). Il termine greco deriva dal perfetto intransitivo del verboeghéirô, “risvegliarsi”, particolarmente significativo perché è uno dei verbi usato per la risurrezione di Gesù.
La vigilanza è quella di chi (il servo «servo buono e fedele») ha fatto fruttare ogni dono ricevuto – ecco così nel seguito del racconto di Matteo la parabola dei talenti (Mt 25,14-30) –, a differenza del servo «malvagio e pigro (Mt 25,26). Naturalmente il “talento” evangelico indicava una moneta assai preziosa del tempo. Pare infatti che un “talento” equivaleva a seimila denari, cioè al salario di seimila giornate lavorative: ovvero fino a venti anni di lavoro.
È a questo punto che Matteo racconta la parabola del giudizio (Mt 25,31-46), quando si compirà il tempo dell’attesa, che è sconosciuto a tutti eccetto al Padre: «quanto a quel giorno e a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo né il Figlio, ma solo il Padre» (Mt 24,36).
La parabola, come è ben noto, si svolge di fronte al trono della gloria del Figlio dell’uomo, quando davanti a lui nella sua condizione definitiva, si raduneranno tutti i popoli della terra.
Egli separerà come il pastore le “pecore” dai “capri” – la traduzione CEI (“capre”) non è esatta –: infatti, solo le prime devono essere munte. Analogamente non può esserci nessun contatto con coloro che vengono chiamati alla destra del Figlio dell’uomo – i benedetti del Padre – a ricevere il regno che è stato preparato per loro fino dalla creazione del mondo e gli altri, alla sinistra.
Il racconto si distende attraverso sette elementi diversi, e tuttavia coerenti fra sé e perfettamente misurabili con le esperienze dei nostri giorni: la fame, la sete, la condizione di straniero, la nudità, la malattia e il carcere. In particolare, il dar da mangiare agli affamati e il vestire gli ignudi, particolari opere di misericordia, sono menzionate particolarmente nella letteratura profetica, e non solo nella religione ebraica…
Queste condizioni di inferiorità sono state soccorse da coloro che hanno compiuto un solo gesto nei confronti di uno solo dei fratelli più piccoli del Signore che giudica: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi più piccoli l’avete fatto a me. Il bene che è stato fatto, oppure negato, raggiunge il figlio dell’uomo attraverso la condizione di coloro che ne prendono il posto. «L’identificazione di Gesù con i fratelli bisognosi si radica nella dedizione senza confini che egli ha rivolto a questi uomini». Il testo dice «questi» (uno solo di questi miei fratelli più piccoli»: Mt 25,40), quasi a significare la loro presenza nel momento del giudizio: sarà questa presenza a rendere concreto l’incontro con Gesù, che giudica le azioni umane in quella «solidarietà sconfinata con tutti i bisognosi sia nella Chiesa sia anche nel mondo» (Gnilka). Sta qui la fonte di un giudizio in atto perennemente sul passato e, soprattutto sul presente, pena la riduzione del messaggio cristiano a pura convenzione.
Successivamente la narrazione evangelica racconta la condizione di coloro che non hanno saputo accogliere le situazioni disagiate dei loro fratelli. La risposta di questi è eloquente è eloquente quanto senza speranza: quando mai ti abbiamo visto in quelle condizioni e non ti abbiamo servito? Il verbo usato qui è quello del servizio ecclesiale, ossia la diakonìa.
La risposta del Figlio dell’uomo non ammette nessuna replica, e difatti si conclude con l’avvio degli ultimi chiamati in causa al supplizio eterno, mentre, gli altri, i giusti andranno verso la vita eterna.
Voglio concludere richiamando la prima lettera di Giovanni: «se uno dice: «Io amo Dio» e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede» (1 Gv 4,20). È la medesima logica che si evidenzia già nel Padre nostro: «rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori» (Mt 6,12).
La condizione del discepolo è sempre consapevole del comando del Signore: «se tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono» (Mt 5,23-24), e contemporaneamente egli prende coscienza del fatto che – ancora la prima lettera di Giovanni – : «noi amiamo perché egli ci ha amati per primo» (1 Gv 4,19)
 di Stefano Tarocchi • Già in precedenza mi sono occupato della lettera agli Ebrei (Il Cristo, «colui che apre la strada»:http://www.).
di Stefano Tarocchi • Già in precedenza mi sono occupato della lettera agli Ebrei (Il Cristo, «colui che apre la strada»:http://www.).