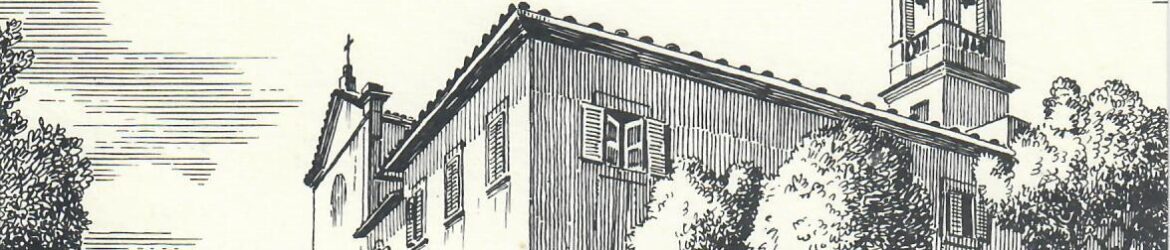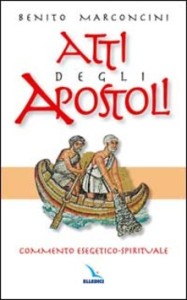Il Mantello della Giustizia – Maggio 2020
Ancora sulla Pasqua ai tempi del virus
 di Stefano Tarocchi · Uno dei pochi elementi positivi che ci sono concessi da questi tempi surreali, ossia la lettura, e soprattutto di un testo recente e denso di Romano Penna (Amore sconfinato. Il Nuovo Testamento sul suo sfondo greco ed ebraico libro, San Paolo 2019) – in particolare di una sezione dedicata alla lettera ai Romani –, ci permette di tornare sul tema della Pasqua.
di Stefano Tarocchi · Uno dei pochi elementi positivi che ci sono concessi da questi tempi surreali, ossia la lettura, e soprattutto di un testo recente e denso di Romano Penna (Amore sconfinato. Il Nuovo Testamento sul suo sfondo greco ed ebraico libro, San Paolo 2019) – in particolare di una sezione dedicata alla lettera ai Romani –, ci permette di tornare sul tema della Pasqua.
Scrive l’apostolo nel cap. 5: «quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui. Se infatti, quand’eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita» (Rom 5,6-10).
Ci sono due frasi in parallelo in questa sezione della lettera ai Romani, entrambe con il verbo «morì» al termine (in questo modo esso è reso l’elemento centrale del ragionamento): Cristo «morì per gli empi», «morì per noi». Paolo parla addirittura del «tempo stabilito», quasi alludendo alla «pienezza dei tempi dei tempi» di cui parla altrove, a proposito della nascita di Gesù (Gal 4,4).
Di fatto l’apostolo muove dall’affermazione che nel momento in cui eravamo ancora “deboli”, ossia incapaci di poter fare da soli a salvarci, avvolti nella nostra incapacità – elemento questo di grande attualità! – , Gesù Cristo è morto per noi. Ma il punto fondamentale consiste nel fatto che Egli è morto per gli empi e per i peccatori, proprio nel momento in cui la condizione umana veniva a trovarsi senza rimedio alcuno: «Egli morì per noi … nel tempo in cui eravamo ancora peccatori, ossia quando non c’era in noi nulla che fosse degno di amore, neppure un atto di pentimento» (R. Penna).
Rifacendosi anche alla tradizione classica, san Paolo parla anche della capacità che, anche se raramente, può verificarsi: ossia che ci può essere qualcuno disposto a morire per un uomo giusto, oppure una persona buona; ma lui paradossalmente è morto per noi mentre eravamo nel peccato e senza nessun merito da produrre.
Già in precedenza l’apostolo aveva affermato che la morte di Gesù aveva preso il posto dello strumento usato nel giorno dell’espiazione: il “propiziatorio”, ossia il coperchio dell’arca dell’alleanza, asperso con il sangue una volta all’anno dal sommo sacerdote (Rom 3,25). Un particolare degno di nota: dopo che l’arca andò perduta al tempo della caduta di Gerusalemme (587 a.C.) il sommo sacerdote, di fatto, aspergeva il pavimento. Quindi siamo stati riconciliati con Dio quando eravamo suoi nemici, totalmente immeritevoli della sua misericordia.
In questo modo «l’apostolo mette in luce il carattere scandaloso di quella morte e della sua intenzionalità, in quanto essa non ha richiesto alcuna predisposizione morale in coloro per i quali è avvenuta. L’amore di Dio è generoso e libero: esso cade su una situazione negativa senza chiedere nulla come condizione previa» (Penna).
Tutto questo richiama la confessione di fede della prima Lettera ai Corinzi: «Cristo morì per i nostri peccati» (1 Cor 15,3): ossia non a causa dei nostri peccati, ma per cancellare i nostri peccati.
Del resto, Paolo aveva esordito così nella stessa sezione: «giustificati [lett. “resi giusti”] dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rom 5,1-5).
E questo ancora una volta ci conduce alla fede, quella di Abramo nella fattispecie: «ecco perché gli fu accreditato [= ad Abramo] come giustizia. E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato, ma anche per noi, ai quali deve essere accreditato: a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione».
Dunque, nel richiamo alla morte scandalosa di Cristo, sta anche la premessa straordinariamente adatta a leggere i segni di questi tempi: «ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rom 5,3-5).