«La Chiesa brucia…». In margine ad un libro di Andrea Riccardi
Il Mantello della Giustizia – Maggio 2021
 di Stefano Tarocchi · Nel saggio recentemente pubblicato da Andrea Riccardi (La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo, Laterza, Bari-Roma 2021), dopo una profonda sintesi storica, nel quarto capitolo l’autore prende espressamente in esame un aspetto delle difficoltà del cattolicesimo contemporaneo: la crisi della vita religiosa. A mio avviso si tratta di un vero e proprio snodo della sua analisi lucida, e una preziosa chiave di lettura.
di Stefano Tarocchi · Nel saggio recentemente pubblicato da Andrea Riccardi (La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo, Laterza, Bari-Roma 2021), dopo una profonda sintesi storica, nel quarto capitolo l’autore prende espressamente in esame un aspetto delle difficoltà del cattolicesimo contemporaneo: la crisi della vita religiosa. A mio avviso si tratta di un vero e proprio snodo della sua analisi lucida, e una preziosa chiave di lettura.
Il volume parte da quell’evento drammatico svoltosi nella laicissima Francia nell’aprile 2019: l’incendio che ha quasi interamente distrutto la cattedrale di Notre-Dame a Parigi, assurto a simbolo di ben altre faccende.
Nelle 248 dense pagine del libro si avverte come il lavoro dello storico riempia di significato tante analisi sociologiche, che corrono rischiano di essere come la nebbia: «lascia il tempo che trova», dicevano i nonni. I dati che fornisce Riccardi dalla sua analisi sono estremamente illuminanti.
La crisi, o le crisi, della Chiesa analizzate da Riccardi richiama, o richiamano, una complessità di situazioni degli anni immediatamente successivi al Concilio, con gli eventi del ‘68 e lo scivolare sia nell’individualismo che nella crisi della figura maschile e la conseguente autorità paterna che perde d’importanza. Tutto ciò mette sotto una luce impietosa i cammini della comunità cristiana: una delle cause il crollo delle vocazioni religiose, maschili e femminili, e di quelle presbiterali sta anche qui. Di quegli anni l’autore cita l’insegnamento pontificio relativo alla trasmissione della vita con l’enciclica Humanae Vitae (1968) dell’allora pontefice Paolo VI, senza di fatto ottenere ascolto, e creando anzi quello che alcuni chiamarono lo “scisma sommerso”
Inoltre, secondo Riccardi, si è anche perso l’occasione di valorizzare la figura femminile senza clericalizzarla. Del resto, la stessa Chiesa d’Inghilterra che pure ammette le donne nel clero fino all’episcopato, non sembra essere riuscita ad affrontare compiutamente tale questione.
Così, verso la conclusione del saggio, Riccardi scrive che «bisogna anche riconoscere l’“avvenimento spirituale” della rivoluzione femminile, nella sinodalità e nella comunione». Perché «crescere vuol dire ritrovarsi attorno alla liturgia, insomma che possa esserci l’eucaristia per piccole o grandi comunità». Quest’ultimo è uno dei compiti più difficili che dovrà essere affrontato senza indugio, e risolto senza porre tempo in mezzo.
D’altronde se l’ekklesìa (la Chiesa) è costituita da quanti sono chiamati a far parte di una comunità a partire da una realtà esterna (ek-kaléo, “chiamare da”) questo aspetto merita un particolare approfondimento, oltre alle situazioni sociologiche proprie delle varie società e degli stati che compongono l’orizzonte europeo, e non solo quello.
Ne sono testimonianza la situazione della chiesa in Francia, in Italia, e, a cascata, nella penisola iberica, da un lato, e dall’altro nei paesi degli ex regimi comunisti in Est Europa.
Da un lato la soluzione che Riccardi chiama le cosiddette democrazie cristiane – i cristiani impegnati in politica come partito, oggi in evidente crisi in Francia, Germania e Italia –, dall’altro i risorgenti nazionalismi e sovranismi, con il rischio di connubi incestuosi fra Chiesa e governi, di strutture statali ed ecclesiastiche che nel nome della difesa di “sacri confini” cercano alleanze che rischiano di travolgere tutti quanti in una stessa crisi irreversibile. Ne è un forte esempio, sempre secondo Riccardi, quello che accade nell’attuale Polonia dove a essere messo in crisi, insieme all’episcopato legato al governo sovranista in carica, è la stessa figura di Giovanni Paolo II, così rapidamente elevata agli onori degli altari.
D’altra parte, non si può trascurare l’immagine di una chiesa che sotto la spinta di Francesco mette al centro l’annuncio del Vangelo – peraltro sulla scia dell’insegnamento di Papa Paolo VI, e, secondo Riccardi, anche di Pio XII che nell’immediato dopoguerra sente forte l’impegno di un rinnovato annuncio. In sostanza, un filo sottile che non può trascurare neanche le figure di Giovanni Paolo II e di Benedetto XIV, che crea il Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Si tratta pertanto di una Chiesa che, sottolinea Riccardi, riscoprendo la sua missione non può dimenticare l’apertura verso nuove forme di testimonianza,
Un passaggio interessante (pp. 117-118) del volume è quando Riccardi fa una riflessione, a mio avviso molto molto acuta, sull’importanza del testo biblico tradotto in italiano dopo il Concilio, la prima ufficiale a firma della Conferenza Episcopale, la cui editio princeps è uscita nel 1971.
Quando viene introdotta la nuova traduzione (2008), che vuole essere più fedele al testo originale – almeno questa era l’intenzione – è mutato in parte il testo italiano delle Scritture, senza tener conto che la memoria di una generazione di fedeli aveva assimilato quello della precedente traduzione. La scelta di una nuova traduzione mostra minor sensibilità all’assimilazione, anche mnemonica della Bibbia, che, dopo il Concilio, voleva essere il libro di un popolo. Non era importante consolidare la memoria accumulatasi tra i fedeli? L’eredità di memoria forgia un linguaggio di fede. E, a mio avviso, non si è ancora accolto in pieno l’importanza dell’operazione introdotta dal Concilio circa le traduzioni del testo sacro nelle lingue correnti.
Un’autorità che vuole affermare dei principi pur corretti ma estranei alla sensibilità del popolo di Dio non tiene conto che la memoria è qualcosa che muove e si muove dal basso, non da coloro che, dall’alto e senza ascoltare nessuno, pretendono di aver la chiavi esclusive per interpretare la parola di Dio, e la stessa volontà dell’Altissimo. Non era forse intenzione del Concilio indicare l’infallibilità del popolo di Dio quando proclama le verità della fede? Così diceva, infatti, Lumen Gentium 12: «la totalità dei fedeli, avendo l’unzione che viene dal Santo, non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando “dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici” mostra l’universale suo consenso in cose di fede e di morale».
«Gli storici, aggiunge Riccardi, hanno ridimensionato le costruzioni mitiche dell’età dell’oro della cristianità in gran parte collocate nel passato. Le crisi ci sono sempre state fin dalle origini. Il grande rischio delle crisi e accontentarsi di sopravvivere, fissi sul presente e confrontandosi solo con un passato migliore … La crisi non è il declino. La via, che può sembrare una non soluzione, è vivere evangelicamente nella crisi» (p. 235).
«Certo c’è qualche decisione da prendere e qualche nodo da sciogliere – conclude Riccardi – : bisogna aver fiducia delle comunità cristiane, dar loro la possibilità di vivere e di provare ad andare verso il futuro, sostenerle nella loro soggettività creativa, che è qualcosa di semplice ed insostituibile, un intreccio tra passione, simpatia, carismaticità. Bisogna avere il coraggio, comunicando il Vangelo, di liberare energie costruttive e creative, di suscitarle, di dare fiducia e sostegno a differenti realtà ecclesiali pur nelle imperfezioni. Si deve lasciar crescere investire sul futuro: è il compito di una generazione. La storia del cristianesimo è anche una vicenda di entusiasmo» (p. 234).
Un giornale tedesco (la Frankfurter Allgemeine Zeitung del 16 aprile scorso) uscito a distanza di due anni esatti dall’incendio della cattedrale di Notre-Dame, mostrando le immagini della sua ricostruzione – che richiederà ancora tre anni prima di poter celebrare nuovamente la Messa –, parla espressamente di “risurrezione”. Certamente se anche quotidiani dall’intensa laicità come quelli tedeschi (e gli stessi quotidiani francesi) percepiscono che intorno alla cattedrale di Parigi e alla sua ricostruzione non c’è stato un abbassamento di tensione (il che è perfettamente immaginabile vedendo come si muovono le notizie nel nostro tempo), allora possiamo dire che può bruciare un tipo di chiesa ma non brucia la chiesa di Cristo.
Che in questa Europa laica e laicista assediata dal virus e pressata nella morsa di tutte le manovre intorno ai vaccini ci sia ancora un segnale di speranza?
Sta a noi percorrerne tutte le strade complicate, nel segno di una Chiesa che si ritrova invariabilmente intorno all’Eucaristia, in presenza (e non per via telematica e a distanza!). E agisce con decisioni concrete e coraggiose, in modo che ogni comunità non ne sia priva ogni volta che si celebra il «giorno del Signore».
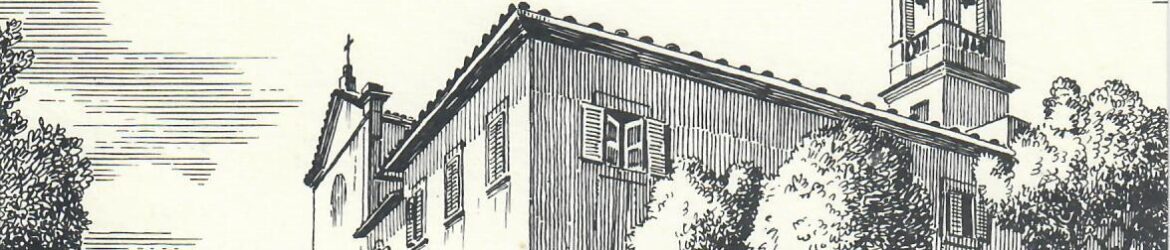
 di Stefano Tarocchi · Fra i vari anniversari che il tempo della pandemia ci ha sottratto, credo vada evidenziata la nascita nell’aprile 1720 di Antonio Martini, arcivescovo di Firenze, morto nel 1809. I suoi studi a Prato e a Pisa, dove si laureò in utroque iure nel 1748, lo portarono fino alla soglia della cattedra di diritto canonico nell’Università di Torino. Divenne invece direttore del Collegio di Superga.
di Stefano Tarocchi · Fra i vari anniversari che il tempo della pandemia ci ha sottratto, credo vada evidenziata la nascita nell’aprile 1720 di Antonio Martini, arcivescovo di Firenze, morto nel 1809. I suoi studi a Prato e a Pisa, dove si laureò in utroque iure nel 1748, lo portarono fino alla soglia della cattedra di diritto canonico nell’Università di Torino. Divenne invece direttore del Collegio di Superga. 
 di Stefano Tarocchi · La pagina di Vangelo assegnata alla prima domenica di Quaresima come ogni anno ci mette di fronte al tempo in cui per quaranta giorni Gesù viene messo alla prova nel deserto dal Satana. Il testo di Marco che abbiamo ascoltato quest’anno utilizza, infatti, l’articolo per determinare la figura dell’avversario di Dio e dell’uomo. Dopo che l’evangelista ha raccontato che lo Spirito discende su Gesù come una colomba, lo stesso Spirito lo spinge con forza nel deserto, laddove viene messo alla prova.
di Stefano Tarocchi · La pagina di Vangelo assegnata alla prima domenica di Quaresima come ogni anno ci mette di fronte al tempo in cui per quaranta giorni Gesù viene messo alla prova nel deserto dal Satana. Il testo di Marco che abbiamo ascoltato quest’anno utilizza, infatti, l’articolo per determinare la figura dell’avversario di Dio e dell’uomo. Dopo che l’evangelista ha raccontato che lo Spirito discende su Gesù come una colomba, lo stesso Spirito lo spinge con forza nel deserto, laddove viene messo alla prova. 
 di Stefano Tarocchi · Roma è l’obiettivo che l’apostolo Paolo ha fortemente voluto nella sua opera di annunciatore del Vangelo ai pagani.
di Stefano Tarocchi · Roma è l’obiettivo che l’apostolo Paolo ha fortemente voluto nella sua opera di annunciatore del Vangelo ai pagani. 