Albert Vanhoye: memoria di un maestro
Il mantello della giustizia – settembre 2021
«Dio avrebbe tanti motivi per non parlare più al suo popolo, ma non si è mai rassegnato!»: è una splendida esclamazione di un uomo intriso della sapienza della Bibbia, indagata e letteralmente ruminata per decenni per essere restituita nella sua densità: il p. Albert Vanhoye, gesuita.
Albert Vanhoye era nato il 24 luglio 1923 a Hazebrouck (diocesi di Lille, in Francia).
Nel 1941, all’età di 18 anni, attraversò tutta la Francia a piedi per entrare nel noviziato della Compagnia di Gesù a Le Vignau (Landes). Un’impresa coraggiosa, quando metà della Francia era occupata dai tedeschi; per raggiungere la zona franca, dovette attraversare la linea clandestinamente per non essere catturato e inviato in Germania per essere aggiunto al numero di giovani che lavoravano per l’industria tedesca.
Dopo una laurea in Lettere classiche, filosofia e teologia a Enghien (Belgio), fu ordinato sacerdote il 25 luglio 1954. Fece il suo “Terzo Anno” (l’anno di formazione spirituale per i gesuiti prima dei loro ultimi voti) a Saint-Martin d’Ablois (1955-56) e pronunciò i suoi voti definitivi a Roma il 2 febbraio 1959.
Nel 1956 fu inviato al Pontificio Istituto Biblico di Roma, per gli studi e, successivamente, per un dottorato, sulla struttura letteraria dell’Epistola agli Ebrei (pubblicato nel 1962).
Insegnò brevemente a Chantilly, prima di tornare a Roma nel 1962, come professore al Pontificio Istituto Biblico. In questa grande istituzione accademica è stato decano della facoltà biblica dal 1969 al 1975, e quindi rettore dell’Istituto biblico dal 1984 al 1990.
Chi scrive l’ha avuto come maestro negli anni tra il 1980 e il 1983, durante gli studi al Pontificio Istituto Biblico: esattamente due corsi e un seminario, sempre sulla lettera agli Ebrei.
Diresse ventotto tesi di dottorato sull’epistola agli Ebrei, su diversi temi della teologia paolina, sull’esegesi dei Vangeli (Marco e Luca), su questioni di struttura letteraria (Libro dell’Apocalisse). Per molti anni segretario della Pontificia Commissione Biblica, è stato una delle grandi ispirazioni di due documenti che estendono l’opera del Concilio: l’interpretazione della Bibbia nella Chiesa (1993) e del popolo ebraico e delle loro sacre Scritture nella Bibbia cristiana (2001).
Fu anche consultore di varie Congregazioni Pontificie (Congregazione dell’Educazione Cattolica; Congregazione per la Dottrina della Fede).
Il cardinale Ratzinger, allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, aveva totale fiducia in lui: si appellava ad Albert Vanhoye ogni volta che un testo papale che menzionava la Scrittura o un libro che commentava la Scrittura causava problemi.
Il Cardinale Ratzinger ha apprezzato questo instancabile, umile lavoratore, che desiderava solo il bene della Chiesa. Fu anche direttore della collana Analecta Biblica.
Il 24 marzo 2006, all’età di 83 anni, è stato creato cardinale da Papa Benedetto XVI per “i servizi che ha reso alla Chiesa con esemplare fedeltà e ammirevole zelo”.
Ha svolto tutte queste funzioni con disponibilità, discrezione ed efficienza. Ciò ha manifestato da un lato un temperamento relativamente timido, ma anche la ricchezza dell’uomo interiore. Come insegnante, i suoi studenti apprezzavano la sua affabile disponibilità per tutti, il suo rigore e la sua preoccupazione per la precisione nell’interpretazione e nella comprensione del testo biblico. Spiritualmente, passò tutta la sua vita a scrutare la figura di Cristo, contemplando la docilità filiale di Gesù verso Dio e la sua solidarietà con gli uomini, lasciandosi guidare al cuore misericordioso di Cristo.
Dal 2013 risiedeva nella comunità di San Pietro Canisio, comunità gesuita, che accoglie in particolare compagni anziani e malati ed è sostenuta dalla Curia Generale dei Gesuiti, accanto al Vaticano: qui morto il 26 luglio 2021 a novantotto anni di vita e sessantasette di sacerdozio.
Anche una lettura sommaria della lista delle opere pubblicate da Albert Vanhoye mostra che il suo pensiero e la sua esegesi erano principalmente nutriti dalla Lettera agli Ebrei. Ha scritto più di cinquanta articoli su altri testi e temi del Nuovo Testamento: ad esempio, sulla composizione di vari passaggi e libri (Giovanni 5, 19-30; 1 Corinzi 12-14; il Benedictus; 1 Tessalonicesi; Apocalisse), sui carismi del Nuovo Testamento, su diversi passi del Vangelo di Giovanni, sull’agonia, la passione e la croce di Cristo, sulla “fede di Cristo”, sui Galati, sul sangue e sul cuore di Cristo, nonché sul rapporto tra esegesi e teologia. Tuttavia, ha pubblicato circa cinquanta studi sulla lettera agli Ebrei: la riprova che questo scritto è rimasto al centro delle sue riflessioni sulla cristologia e la tipologia del Nuovo Testamento, nonché sull’Antica e la Nuova Alleanza.
A noi rimane il suo insegnamento, la sua sapienza, sempre ricca di contenuto e di spessore: P. Vanhoye ci lascia quasi il compito di ritrovare il giusto spazio per questo libro del Nuovo Testamento, tanto importante, quanto ingiustamente trascurato negli studi di teologia, che mette particolarmente in luce il sacerdozio di Cristo e quello del popolo di Dio. La lettera agli Ebrei del Nuovo Testamento dovrà nuovamente e con maggior forza essere affidato alla lettura e allo studio dei candidati al ministero presbiterale, ma anche di quanti compiono i loro studi per conseguire i gradi accademici. È un impegno che mi assumo nella memoria del mio antico maestro.
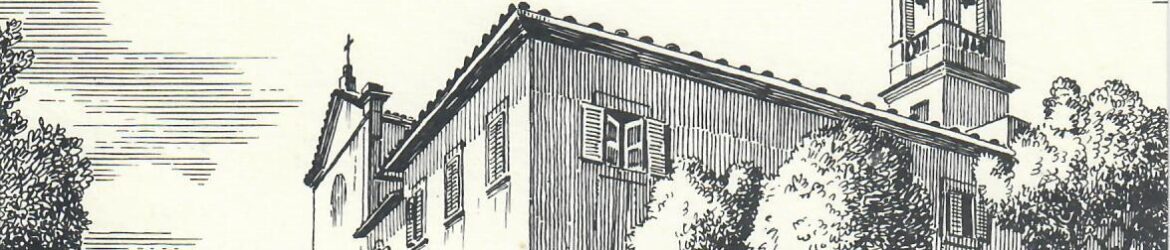

 di Stefano Tarocchi · Il testo di Marco del celebre insegnamento sul tributo a Cesare (Mc 12,14 e paralleli), ambientato nel tempio di Gerusalemme, è centrale all’interno della triplice tradizione sinottica.
di Stefano Tarocchi · Il testo di Marco del celebre insegnamento sul tributo a Cesare (Mc 12,14 e paralleli), ambientato nel tempio di Gerusalemme, è centrale all’interno della triplice tradizione sinottica. di Stefano Tarocchi · Nel libro degli Atti è ben conosciuto l’episodio di Pietro che a Cesarea marittima si incontra, chiamato dallo Spirito con il centurione Cornelio, i suoi familiari e i suoi amici, che si conclude con la discesa dello Spirito su quanti non erano stati ancora battezzati: «i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in lingue e glorificare Dio» (At 10,45-46) [Per la verità la traduzione CEI 2008 riporta «parlare in lingue», con l’aggiunta dell’aggettivo “altre”, che nel testo greco non esiste: sicuramente un refuso per assonanza ad altri testi degli Atti].
di Stefano Tarocchi · Nel libro degli Atti è ben conosciuto l’episodio di Pietro che a Cesarea marittima si incontra, chiamato dallo Spirito con il centurione Cornelio, i suoi familiari e i suoi amici, che si conclude con la discesa dello Spirito su quanti non erano stati ancora battezzati: «i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in lingue e glorificare Dio» (At 10,45-46) [Per la verità la traduzione CEI 2008 riporta «parlare in lingue», con l’aggiunta dell’aggettivo “altre”, che nel testo greco non esiste: sicuramente un refuso per assonanza ad altri testi degli Atti].  abbiamo: «io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco» (Mt 3,11).
abbiamo: «io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco» (Mt 3,11).