Intanto, va detto che è cambiato il destinatario iniziale. Papa Francesco così spiega: «inizialmente avevo scritto un titolo riferito alla formazione sacerdotale, ma poi ho pensato che, analogamente, queste cose si possono dire circa la formazione di tutti gli agenti pastorali, come pure di qualsiasi cristiano».
Francesco parla del «valore della lettura di romanzi e poesie nel cammino di maturazione personale», perché in sostanza «la potenza spirituale della letteratura richiama, da ultimo, il compito primario affidato da Dio all’uomo: il compito di “nominare” gli esseri e le cose (cf. Gen 2, 19-20). La missione di custode del creato, assegnata da Dio ad Adamo, passa innanzitutto proprio dalla riconoscenza della realtà propria e del senso che ha l’esistenza degli altri esseri. Il sacerdote è anche investito di questo compito originario di “nominare”, di dare senso, di farsi strumento di comunione tra il creato e la Parola fatta carne e della sua potenza di illuminazione di ogni aspetto della condizione umana».
«Che cosa guadagna il sacerdote – ed ogni credente – da questo contatto con la letteratura? Perché è necessario considerare e promuovere la lettura dei grandi romanzi come una componente importante della paideia sacerdotale? Perché è importante recuperare e implementare nel percorso formativo dei candidati al sacerdozio l’intuizione, delineata dal teologo Karl Rahner, di un’affinità spirituale profonda tra sacerdote e poeta?».
Ma il papa Francesco non esprime solo un richiamo – anche questo mai sottolineato abbastanza – allo studio serio della teologia nella formazione (permanente?) dei presbiteri, che, di questi tempi, rischia di essere vista una tassa da pagare a chi sostiene di aver ricevuto la chiamata divina (e, forse, sottovalutato nella considerazione di formatori non abbastanza attenti ai segni dei tempi). Purtroppo, stando così le cose, temo che ne pagheremo le conseguenze fra non molto tempo.
Il papa parla espressamente della letteratura, del libro scritto, ossia dell’esperienza di incontrare l’umano nel testo pubblicato come libro, che richiede un impegno attivo a differenza della sua trascrizione in immagini. In questo senso la lettura di un libro non è differente dalla lettura di un dipinto di alto profilo, opera di un vero artista e non tanto di un abile artigiano.
Per questo, la grande letteratura, è anche confronto, ad esempio con un non credente alla ricerca dei semina Verbi. Di fatto, possiamo riconoscere un simile approccio negli Atti degli Apostoli, lì dove si parla della presenza di Paolo all’Areopago (cf. At 17,16-34). Scrive Francesco: «Paolo, parlando di Dio, afferma: «In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto: “Poiché di lui stirpe noi siamo» (At 17,28). In questo versetto sono presenti due citazioni: una indiretta nella prima parte, dove si cita il poeta Epimenide (VI sec. a. C.), ed una diretta, che cita i Fenomeni del poeta Arato di Soli (III sec. a. C.), il quale canta le costellazioni e i segni del buono e cattivo tempo».
«Paolo si rivela “lettore” di poesia e lascia intuire il suo modo di accostarsi al testo letterario, che non può non far riflettere in ordine a un discernimento evangelico della cultura. [Nel testo greco originale], egli viene definito dagli ateniesi spermològos, cioè “cornacchia, chiacchierone, ciarlatano”, ma letteralmente “raccoglitore di semi”. Quella che era certamente un’ingiuria sembra, paradossalmente, una verità profonda. Paolo raccoglie i semi della poesia pagana e, uscendo da un precedente atteggiamento di profonda indignazione (cf. At 17,16), giunge a riconoscere gli ateniesi come “religiosissimi” [anche se il termine allude al timore della divinità!] e vede in quelle pagine della loro letteratura classica una vera e propria preparatio evangelica».
Paolo «ha compreso che la “letteratura scopre gli abissi che abitano l’uomo, mentre la rivelazione, e poi la teologia, li assumono per dimostrare come Cristo giunge ad attraversarli e a illuminarli”. In direzione di questi abissi, la letteratura è dunque una “via d’accesso”, che aiuta il pastore – qui il termine usato riporta all’impianto iniziale – a entrare in un fecondo dialogo con la cultura del suo tempo».
Per arrivare a noi, Graham Greene amava definirsi non uno scrittore cattolico ma un cattolico – tormentato e controverso, e anche messo all’Indice! –, che era scrittore. Se non altro era in buona compagnia nell’ Indice dei libri proibiti, l’elenco – secondo la definizione del vocabolario Treccani – dei libri di cui la «Chiesa, per ragioni dottrinali e morali, condannava con gravi sanzioni la lettura, la pubblicazione e la diffusione». In quell’Index Librorum Prohibitorum voluto da Paolo IV nel 1559, sono finiti il Decamerone di Boccaccio, l’Elogio della Follia di Erasmo da Rotterdam e il Principe di Machiavelli. Pubblicato inizialmente (1557-1571) ad opera del Sant’Uffizio, fu curato in seguito (e fino al 1917!) dalla Congregazione dell’Indice, e successivamente da una sezione della Congregazione del Sant’Uffizio, oggi Dicastero per la Dottrina della Fede. Tale istituto, com’è noto, venne abolito tecnicamente solo nel giugno del 1966, con una notificazione a firma del card. Ottaviani, che faceva seguito alla Lettera apostolica di Paolo VI del dicembre 1965, all’immediata vigilia della conclusione del Concilio.
Peraltro, in pieno conflitto mondiale, già Benedetto XV nel 1917 con un motu proprio aveva soppresso la Congregazione dell’Indice, che da allora diventava una sezione del Sant’Uffizio, cui veniva conferito il compito di «esercitare la censura su libri ed altri scritti». Si comprende bene perché un decreto dell’allora da poco ribattezzata Congregazione per la dottrina della fede (novembre 1966) faceva ancora riferimento all’obbligo di «ricordare nuovamente il valore della legge morale, che vieta assolutamente di mettere in pericolo la fede e i buoni costumi». E tuttavia, tale decreto ricordava che, da quel momento in poi, «coloro che sono incorsi in censure … devono essere considerati da esse assolti, per il fatto stesso dell’abrogazione del canone in parola». Una formula drastica quanto pragmatica!
Già Paolo VI, nella lettera apostolica scriveva che l’organismo pontificio, creato integrae servandae revelatae Religionis depositum, affidava il compito di «esaminare con diligenza i libri che le vengono segnalati e, se sarà necessario, li condannerà, dopo aver tuttavia sentito l’autore, al quale si darà la facoltà di difendersi, anche per iscritto, e non senza aver prima avvertito l’ordinario, come è già stato stabilito nella Costituzione Sollicita ac provida di Benedetto XIV». Questo prima che la notificazione di Ottaviani chiarisse determinati aspetti.
Ma c’è un altro nome e un altro riferimento che ricorre nella lettera del papa del concilio: si tratta ancora di un Paolo, Paolo III Farnese, che nel 1542 aveva fondato la Sacra Congregazione dell’Inquisizione Romana ed Universale. E il nome diceva tutto.
Non si può non avvertire che molta acqua è scorsa sotto i ponti del Tevere, se papa Francesco, nella sua lettera, vergata in maniera quasi rapsodica, definisce la «letteratura come la possibilità di sperimentare nell’arco breve della vita umana infinite letture e punti di vista». Essa «ha così a che fare, in un modo o nell’altro, con ciò che ciascuno di noi desidera dalla vita, poiché entra in un rapporto intimo con la nostra esistenza concreta, con le sue tensioni essenziali, con i suoi desideri e i suoi significati».
Per questo, «la letteratura ci aiuta a dire la nostra presenza nel mondo, a “digerirla” e assimilarla, cogliendo ciò che va oltre la superficie del vissuto; serve, dunque, a interpretare la vita, discernendone i significati e le tensioni fondamentali». Così possiamo concordare con chi ha scritto che non siamo noi a cercare un libro, ma è un libro a cercare noi, come è stato affermato.
Pertanto, «lo sguardo della letteratura forma il lettore al decentramento, al senso del limite, alla rinuncia al dominio, cognitivo e critico, sull’esperienza, insegnandogli una povertà che è fonte di straordinaria ricchezza. Nel riconoscere l’inutilità e forse pure l’impossibilità di ridurre il mistero del mondo e dell’essere umano ad una antinomica polarità di vero/falso o giusto/ingiusto, il lettore accoglie il dovere del giudizio non come strumento di dominio ma come spinta verso un ascolto incessante e come disponibilità a mettersi in gioco in quella straordinaria ricchezza della storia dovuta alla presenza dello Spirito, che si dà anche come Grazia: ovvero come evento imprevedibile e incomprensibile che non dipende dall’azione umana, ma ridefinisce l’umano come speranza di salvezza».
Così «nella violenza, limitatezza o fragilità altrui, abbiamo la possibilità di riflettere meglio sulla nostra. Nell’aprire al lettore un’ampia visione della ricchezza e della miseria dell’esperienza umana, la letteratura educa il suo sguardo alla lentezza della comprensione, all’umiltà della non semplificazione, alla mansuetudine del non pretendere di controllare il reale e la condizione umana attraverso il giudizio. Vi è certo bisogno del giudizio, ma non si deve mai dimenticare la sua portata limitata: mai, infatti, il giudizio deve tradursi in sentenza di morte, in cancellazione, in soppressione dell’umanità a vantaggio di un’arida totalizzazione della legge». Un’allusione al famigerato Indice?
«In questo senso la letteratura aiuta il lettore ad infrangere gli idoli dei linguaggi autoreferenziali, falsamente autosufficienti, staticamente convenzionali, che a volte rischiano di inquinare anche il nostro discorso ecclesiale, imprigionando la libertà della Parola».
In parte questo pensiero rimanda a quell’“ipertrofia dell’ego” che caratterizza tanti tratti della nostra contemporaneità, non esclusi quelli intra-ecclesiali.
Perciò, «quella letteraria è una parola che mette in moto il linguaggio, lo libera e lo purifica: lo apre, infine, alle proprie ulteriori possibilità espressive ed esplorative, lo rende ospitale per la Parola che prende casa nella parola umana, non quando essa si auto comprende come sapere già pieno, definitivo e compiuto, ma quando essa si fa vigilia di ascolto e attesa di Colui che viene per fare nuove tutte le cose (cf. Ap 21, 5)».

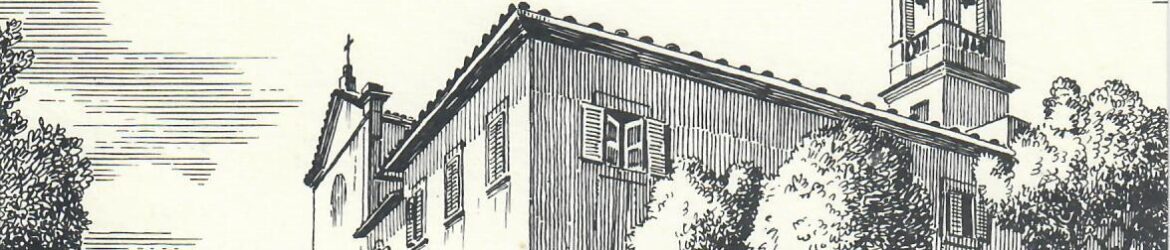
 La lettera di papa Francesco pubblicata nello scorso luglio sul ruolo della letteratura nella formazione, quasi in silenzio nel vortice ferocemente folle della comunicazione, ha forse scelto un tema d’antan nel tempo della comunicazione in tempo reale?
La lettera di papa Francesco pubblicata nello scorso luglio sul ruolo della letteratura nella formazione, quasi in silenzio nel vortice ferocemente folle della comunicazione, ha forse scelto un tema d’antan nel tempo della comunicazione in tempo reale?