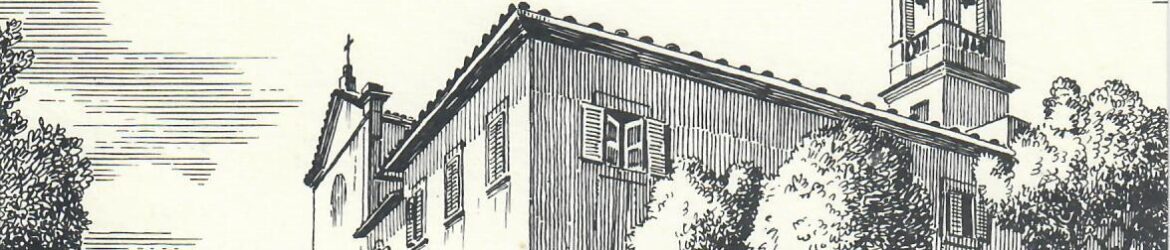di Stefano Tarocchi •Corrado Augias in Le ultime diciotto ore di Gesù (Einaudi, Torino 2015) crea un lungo racconto romanzato sulla passione di Cristo, ma non riesce ad uscire dal suo ruolo di giornalista: è evidente che gli piace indugiare nello spiegare quello che narra, facendo a meno delle fonti (anche se vedremo che delle fonti esistono eccome) ed usando spesso il suo istinto come fonte. Questo, in sintesi, il percorso della sua “analisi”.
di Stefano Tarocchi •Corrado Augias in Le ultime diciotto ore di Gesù (Einaudi, Torino 2015) crea un lungo racconto romanzato sulla passione di Cristo, ma non riesce ad uscire dal suo ruolo di giornalista: è evidente che gli piace indugiare nello spiegare quello che narra, facendo a meno delle fonti (anche se vedremo che delle fonti esistono eccome) ed usando spesso il suo istinto come fonte. Questo, in sintesi, il percorso della sua “analisi”.
Nella narrazione, troviamo colte citazioni da Orazio a Cicerone al Qoelet (o Koheleth): la chiave per capire con gli occhi dello scrittore che apparentemente descrive le «ultime diciotto ore» della vita di Gesù ma rimane affascinato da tutto il complesso universo in cui il racconto si svolge. Salvo poi creare dialoghi dal vago genere filosofico, come quello tra la moglie di Pilato e Lucilio, o introdurre sul genere flash-back testimonianze dei protagonisti o sue personali digressioni, dal sapore fortemente didascalico. Si aggiunge a tutto questo qualche rapida incursione in scene pruriginose, in pendant con la pornografia della violenza e del sangue cara a certe letture della passione, fondamentalmente estranee per chi conosce e legge i Vangeli canonici. Descrizioni romanzate di costume di Augias, che strizza l’occhio al lettore, dei corrotti e corruttibili funzionari romani e delle loro debolezze anche fisiche?
Evidentemente il film di Gibson sulla passione, col suo irrefrenabile bisogno di mostrare sangue e violenza, gli appare una specie di faro di sapienza a confronto della sobrietà dei Vangeli circa gli eventi drammatici che precedono la morte di Gesù. Gli stessi Vangeli canonici, secondo Augias, sono: 1) testi al servizio di un’ideologia e non di una biografia, sia pure apologetica, anche se, aggiunge, molti considerano attendibili quei testi, ricavando un senso di rassicurazione e di speranza – concede con indulgenza – sono solo «testi edificanti»; 2) testi che sono frutto della fede più che della storia; 3) nessuno dei testi è stato scritto da testimoni diretti dei fatti. Gli scritti di Matteo, Marco, Luca e Giovanni sono sempre di parte: si intende, dalla parte dei Romani, secondo Augias. Gli è evidentemente più gradito e più consono il Vangelo gnostico di Tommaso.
Augias anche si comporta quasi da navigato esegeta, quando spiega il termine greco ptochòs, «povero», lascia tuttavia (un lapsus?) che il suo lettore creda che la Pasqua dell’anno 33 si svolga il giorno stesso della morte di Gesù – che invece, come scrive Giovanni, è il giorno dopo la sua morte –, e il sommo sacerdote Caifa, ritratto con la prudenza melliflua di un funzionario di polizia d’altri tempi, possa usare nel suo resoconto da romanzo d’appendice sul processo a Gesù, termini come plenum per riferirsi all’assemblea del Sinedrio (765).
Quando, quasi per caso, cita per la prima volta Gesù nella nostra lingua (328) ciò avviene attraverso gli occhi di Pilato. Prima aveva usato la traslitterazione della lingua ebraica: Joshua ben Joseph ha-Nozri (63: la numerazione è quella dell’edizione ebook), poi solamente Joshua (375), che vive con il padre Joseph, naturalmente «falegname», anche se Augias parla di un «carpentiere», con quattro figli e due figlie, che vive con Myriam, naturalmente Maria e quello che lo scrittore chiama il segreto di lei: ogni rimando al racconto del vangelo di Matteo (o tantomeno di Luca) non viene neanche preso in considerazione, ma si sa questi sono i Vangeli dei semplici, che gli intellettuali guardano con sufficienza…
Pilato evidentemente dev’essere molto caro ad Augias, tanto che il lettore, talora, non distingue il pensiero dell’uno dalla descrizione dell’altro. È così che Pilato, secondo Augias, emette una sentenza di morte in base a valutazioni complesse: secondo Filone (Legatio ad Gaium) emerge di lui «la corruttibilità e la violenza, l’insopportabile crudeltà» (quest’ultima, secondo lo scrittore, lo avvicina ad Erode, ed in particolare, alla strage degl’innocenti), mentre i Vangeli, scrive ancora, dipingono Pilato «nobilmente lacerato» (?!). Caifa è perfidamente rappresentato nell’«impedire che i Romani mandassero sull’atroce patibolo della croce un ebreo… così amato dal popolo… e tentare in extremis di salvarlo» (altra espressione latina: 765!).
Quindi lo scrittore inframezza con divagazioni quello che poteva essere un saggio di indagine storica (cf. ad esempio, Willibald Bösen, L’ultimo giorno di Gesù di Nazaret, Elledici, Leumann (TO) 2007) e diventa invece un pamphlet. Così Augias ha di fatto creato la sua fiction, termine che, sottolinea egli stesso, deriva dal sostantivo latino fictio e dal verbo latino fingere. Per questo l’idea difiction, cara all’autore, gli offre numerosi significati utili alla descrizione di quanto va scrivendo: “figurarsi”, “immaginare”, “supporre”, “ipotizzare” (97). E Augias fa proprio così, mescolando sapientemente le fonti, a seconda delle sue preferenze e dei suoi gusti, che richiama al termine del libro: da Bulgakov a Giuseppe Flavio, da Hengel a Jeremias, da Lohse a Romano Penna, da Renan a Saramago, da Artemidoro a Lucrezio, da Vito Mancuso a Remo Cacitti a Mauro Pesce e Marco Vannini.
Va riconosciuto che, come è suo solito, è capace di farsi leggere, cosa non da poco. Ma il risultato, a mio avviso, rimane sempre inadeguato di fronte alla grandezza del tema, e, sebbene indubbiamente affascinato dal Cristo, l’autore rimane avviluppato in una indomabile ambiguità.