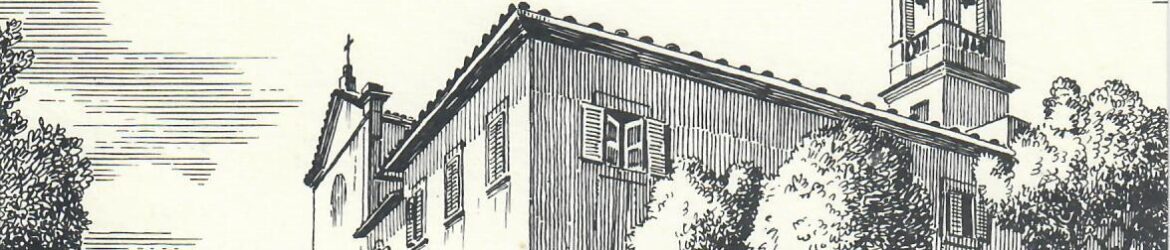«Ti sei appellato a Cesare, a Cesare andrai». Paolo a Roma.
 di Stefano Tarocchi · Roma è l’obiettivo che l’apostolo Paolo ha fortemente voluto nella sua opera di annunciatore del Vangelo ai pagani.
di Stefano Tarocchi · Roma è l’obiettivo che l’apostolo Paolo ha fortemente voluto nella sua opera di annunciatore del Vangelo ai pagani.
Ce lo dice lui stesso nella lettera che ha indirizzato ai cristiani di Roma, fino dalle prime righe: «desidero ardentemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, perché ne siate fortificati, o meglio, per essere in mezzo a voi confortato mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Non voglio che ignoriate, fratelli, che più volte mi sono proposto di venire fino a voi – ma finora ne sono stato impedito – per raccogliere qualche frutto anche tra voi, come tra le altre nazioni. Sono in debito verso i Greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti: sono quindi pronto, per quanto sta in me, ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma» (Rom 1,11-15). Di Roma e Paolo mi sono occupato qualche tempo fa: 〈vedi〉.
Secondo questo scritto, composto nella maturità del suo ministero e indirizzato ad una comunità che non è stata fondata da lui, Paolo vuole andare a Roma perché sente di aver concluso la sua esperienza di annuncio del vangelo in tutto l’Oriente: «da Gerusalemme e in tutte le direzioni fino all’Illiria, ho portato a termine la predicazione del vangelo di Cristo». E dunque «non trovando più un campo d’azione in queste regioni e avendo già da parecchi anni un vivo desiderio di venire da voi, spero di vedervi, di passaggio, quando andrò in Spagna, e di essere da voi aiutato a recarmi in quella regione, dopo avere goduto un poco della vostra presenza» (Rom 15,19.23-24).
Nel libro degli Atti, tuttavia, sembra ci sia un’altra ragione dell’arrivo di Paolo nella capitale dell’impero. Leggiamo il racconto, nello stile tipico delle narrazioni dei viaggi: «arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Dopo tre giorni, egli fece chiamare i notabili dei Giudei e, quando giunsero, disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo o contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rimettermi in libertà, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i Giudei si opponevano, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere, con questo, muovere accuse contro la mia gente. Ecco perché vi ho chiamati: per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza d’Israele che io sono legato da questa catena» (At 28,16-20).
Circa la data dell’arrivo, ci aiuta san Girolamo, secondo cui «Paolo viene mandato prigioniero a Roma nell’anno venticinquesimo dopo la Passione del Signore, cioè nel secondo anno di Nerone, al tempo in cui Festo succede a Felice come procuratore della Giudea fu inviato prigioniero a Roma e, rimanendo in libertà vigilata per un biennio, ogni giorno disputava contro i Giudei sulla venuta di Cristo». Siamo quindi nell’anno 55 d.C., poco prima dell’inverno, quando, nei tempi antichi, il mare era “chiuso” alla navigazione fino alla primavera successiva. La navigazione del tempo infatti era legata al modo di governare le navi, e chi si metteva in mare oltre ogni regola di prudenza rischiava il naufragio.
Anche una visione, narrata precedentemente, gli preannuncia il viaggio a Roma quando a Gerusalemme si trova in pericolo di vita: «Coraggio! Come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma» (At 23,11). E, ancora, durante il naufragio a Malta, narra il libro: «mi si è presentato infatti questa notte un angelo di quel Dio al quale io appartengo e che servo, e mi ha detto: “Non temere, Paolo; tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi compagni di navigazione”» (At 27,23-24).
Quando Paolo giunge a Roma, è lui stesso a rivela che il suo arrivo è dovuto alla circostanza dell’“appello a Cesare”, di cui parla lo stesso libro più volte.
Gli Atti degli Apostoli fanno riferimento ad un istituto giuridico: la «provocatio», che consisteva nel rivolgersi prima del processo a una corte di grado superiore che avrebbe avocato a sé l’intera causa, sottraendola alla corte di grado inferiore. Il procedimento era racchiuso nella lex Valeria de provocatione, attribuita al console Publio Valerio Publicola (siamo nel 509 a.C.): all’interno della città di Roma ciascun cittadino avrebbe potuto limitare il potere dei consoli ricorrendo alla provocatio ad populum: era consentito richiedere un giudizio innanzi alle assemblee popolari. In età imperiale la provocatio si rivolgeva all’imperatore, e così l’appello.
Ma perché Paolo vuole espressamente fare ricorso a Cesare?
Secondo il libro degli Atti, quando arriva a Gerusalemme viene accusato da aver violato la sacralità del tempio. Dapprima pronuncia la sua autodifesa (At 22,1-21), raccontando per la seconda volta la sua chiamata, e quindi, visto il pericolo di vita che incombe su di lui – un vero e proprio complotto (At 23,12-22) – viene trasferito a Cesarea, dopo che ha scampato alla flagellazione quando il centurione rivela al tribuno che Paolo è cittadino romano. E questi precisa che lo è fin dalla dalla nascita (At 22,28). Vi rimarrà due anni in prigione, quando Felice, uomo di cui gli Atti narrano la chiara venalità, lascia l’incarico a Porcio Festo, giunto alla scadenza del proprio mandato.
Così leggiamo nel libro degli Atti: «Paolo disse a propria difesa: «Non ho commesso colpa alcuna, né contro la Legge dei Giudei né contro il tempio né contro Cesare». Ma Festo, volendo fare un favore ai Giudei, si rivolse a Paolo e disse: «Vuoi salire a Gerusalemme per essere giudicato là di queste cose, davanti a me?». Paolo rispose: «Mi trovo davanti al tribunale di Cesare: qui mi si deve giudicare. Ai Giudei non ho fatto alcun torto, come anche tu sai perfettamente. Se dunque sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di morire, ma, se nelle accuse di costoro non c’è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io mi appello a Cesare». Allora Festo, dopo aver discusso con il consiglio, rispose: «Ti sei appellato a Cesare, a Cesare andrai». In conclusione, a parlare è ancora Porcio Festo: «Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare» (At 25, 21).
E ancora: «Io mi sono reso conto che egli non ha commesso alcuna cosa che meriti la morte. Ma poiché si è appellato ad Augusto, ho deciso di inviarlo a lui. Sul suo conto non ho nulla di preciso da scrivere al sovrano; per questo l’ho condotto davanti a voi e soprattutto davanti a te, o re Agrippa, per sapere, dopo questo interrogatorio, che cosa devo scrivere. Mi sembra assurdo infatti mandare un prigioniero, senza indicare le accuse che si muovono contro di lui» (At 25,25-27). E quindi: «andandosene, conversavano tra loro e dicevano: «Quest’uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene». Nel frattempo, davanti al re Erode Agrippa II, racconta ancora una volta la sua chiamata in una nuova autodifesa (At 26,1-23).
È al termine di questa che Erode Agrippa, dopo aver dato di pazzo all’apostolo, dice a Festo: «Quest’uomo poteva essere rimesso in libertà, se non si fosse appellato a Cesare» (At 26,31-32).
Il libro degli Atti, in questi due ultimi passaggi, evidenzia un particolare degno di nota – e di rilevanza giuridica –, ripetuto due volte: Paolo non ha commesso alcuna cosa che meriti la morte (At 26,25); non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene (At 26,31).
Festo può solo evidenziare le accuse per rendere credibile l’appello a Cesare
Paolo morirà di lì a poco dopo il suo arrivo, nel 58 d.C., dopo due anni di libertà vigilata (cf. At 28,30), oppure nel 67 d.C. (Girolamo ed Eusebio di Cesarea). 
In questo secondo caso avrebbe affrontato un primo processo, da cui sarebbe scampato per affrontare un viaggio (probabilmente fallimentare) in Spagna, e, tornato in Oriente sarebbe rientrato a Roma, dove subisce il martirio. In questo modo si esprimono le fonti antiche, basate sulla seconda lettera a Timoteo, che appartiene della tradizione paolina e non di pugno dell’apostolo.
Il libro degli Atti non dice niente di questo: si ferma al tempo dei due anni di libertà vigilata. Fra l’altro, non racconta di nessun rapporto di Paolo con la comunità di Roma, né tanto meno con la Roma imperiale. Soprattutto non parla della sua passione, forse per non mettere in ombra la passione di Cristo.
In ogni caso, la passione di Paolo, qualunque sia stato l’anno in cui è avvenuta, è stata determinata in un consesso legalmente legittimo. Così che, quando l’apostolo scrive alla chiesa di Roma, nella conclusione della lettera afferma solennemente il principio divino dell’autorità: «ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite. Infatti, non c’è autorità se non da Dio: quelle che esistono sono stabilite da Dio» (Rom 13,1). E il primo a testimoniarlo è lo stesso apostolo, quando afferma per inciso: «parlo a gente che conosce la legge» (Rom 7,1).
L’appello a Cesare non era dettato dalla ricerca di un teatro più importante – anche Gesù è stato condannato a morte dall’autorità di Roma – ma l’evento con cui la provvidenza divina ha legato Roma alla nascente fede cristiana.
È così che Roma assume un valore importante per la storia del cristianesimo nei secoli. Come ebbe a dire in un discorso a braccio Giovanni Paolo II: «i vescovi di Roma non devono considerarsi soltanto successori di Pietro, ma anche come gli eredi di Paolo».
Ed ecco allora l’attualità del messaggio di una Chiesa in uscita, come sulle orme di san Paolo ripete l’attuale vescovo di Roma, papa Francesco, per «uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (Evangelii Gaudium 20).